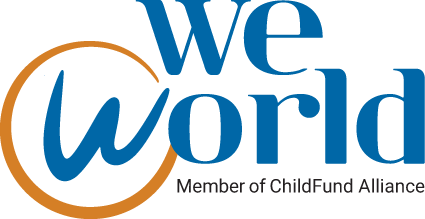Il cambiamento climatico non colpisce solo l’ambiente: colpisce anche le persone, e non tutte allo stesso modo. Le donne e le ragazze, in molti contesti, sono tra le più esposte alle sue conseguenze. La crisi climatica accentua le disuguaglianze e rende più difficile la vita di chi ha meno risorse, meno potere e meno protezione. Quando l’acqua scarseggia, mantenere una corretta igiene mestruale diventa complicato. Quando le donne sono costrette a spostarsi per siccità o alluvioni, aumenta il rischio di violenza sessuale. Il cambiamento climatico influisce anche sulla salute sessuale e riproduttiva, ma questo legame è ancora poco riconosciuto. È un tema che riguarda milioni di donne e ragazze nel mondo e che merita più attenzione nelle politiche e nelle azioni per il clima.
La crisi climatica non è neutra: perché serve parlare di potere, decolonialità e femminismo
La crisi climatica non è neutra. Colpisce in modo diverso a seconda di dove si nasce, di quanto si possiede, di quale ruolo si occupa nella società, del proprio genere e di tanti altri fattori. E spesso, a pagarne il prezzo più alto, sono proprio donne, ragazze e bambine, che vivono le conseguenze del cambiamento climatico insieme a quelle delle disuguaglianze di genere già esistenti. Oggi parlare di crisi climatica significa parlare anche di giustizia sociale e di parità dei generi: di come redistribuire risorse, colmare le disuguaglianze e proteggere i diritti di chi è più esposto agli effetti del cambiamento.
Di questo, e di molto altro, si occupa il nostro ultimo studio “On Our Lands, On Our Bodies”, presentato in anteprima alla 30ª Conferenza sul Clima (COP30) di Belém, in Brasile, e realizzato in collaborazione con il centro di ricerca ARCO. La ricerca analizza come il cambiamento climatico influenzi la salute sessuale e riproduttiva delle donne, in particolare nelle comunità indigene e rurali. Si concentra su esperienze provenienti da Brasile, Kenya e Tanzania, dove le trasformazioni ambientali stanno modificando profondamente la vita quotidiana. Il lavoro si ispira ai principi dell’ecofemminismo e adotta una prospettiva decoloniale: mette al centro la conoscenza, le esperienze e la leadership delle comunità locali, riconoscendone sia le fragilità sia la capacità di reagire e trovare soluzioni. Attraverso questo approccio vogliamo contribuire a costruire risposte più giuste e adeguate alle crisi intrecciate del cambiamento climatico e della disuguaglianza di genere.
“Ho iniziato a sentire la temperatura corporea salire molto (molti periodi di caldo), impazienza e brividi. Ho avuto palpitazioni e molti mal di testa. Il caldo rendeva il mio corpo ancora più agitato." - intervista tratta da On Our Lands, On Our Bodies - Brasile
Quest’anno la COP30 dedica un’attenzione particolare alle comunità indigene. È un’occasione importante per cambiare prospettiva e riportare al centro le voci dei territori e delle persone più colpite dalla crisi climatica. Per farlo, serve però un approccio femminista e decoloniale alla giustizia climatica. Questo significa riconoscere le strutture di potere che generano disuguaglianze e dare valore ai saperi locali, alle pratiche di adattamento e alle forme di resistenza collettiva. Un approccio di questo tipo permette di intrecciare la transizione ecologica con la redistribuzione di potere, risorse e tempo. Non basta “includere” le donne o le comunità locali nei processi decisionali: bisogna cambiare le priorità e i modelli su cui si basano. Ripensare la transizione ecologica significa mettere al centro la cura, la giustizia sociale, la parità dei generi, la sovranità e la conoscenza dei territori. Solo così la lotta al cambiamento climatico può essere davvero equa e sostenibile.
"Quando ci sono gravi siccità, tutto ne risente, soprattutto la vita delle donne. Quando succede, andiamo alla ricerca di pacchi di cibo di base, le donne non lascerebbero mai che le loro famiglie soffrissero la fame. La siccità aumenta anche la disoccupazione femminile, perché le persone hanno meno soldi per pagare servizi come le pulizie domestiche." - intervista tratta da On Our Lands, On Our Bodies – Brasile
Tre Paesi, tante voci: un’indagine partecipativa
Con questa ricerca, abbiamo voluto capire cosa succede quando la crisi climatica colpisce direttamente la vita quotidiana: quando le risorse si riducono, quando le persone sono costrette a spostarsi, quando i servizi sanitari diventano difficili da raggiungere. Tutto questo ha un impatto profondo, soprattutto per donne e ragazze, che spesso si trovano a dover affrontare nuove barriere nel tutelare la propria salute e i propri diritti.
Lo studio indaga non solo come le persone percepiscono il cambiamento climatico, ma anche quali effetti concreti abbia sui loro corpi, sulle loro famiglie e sulle loro comunità. Il nostro obiettivo è capire come proteggere meglio la salute e i diritti di chi vive ogni giorno gli effetti della crisi climatica, e fare in modo che la salute sessuale e riproduttiva sia parte integrante delle strategie di adattamento al clima.
“Quello che percepisco è che le donne sono molto stanche, più esauste. Ci sono livelli molto alti di malattie mentali tra le donne indigene. Molte assumono farmaci da prescrizione, hanno difficoltà a dormire e sono sopraffatte dal lavoro. C'è un sovraccarico significativo di lavoro domestico e la malattia mentale sta diventando una bomba a orologeria in questi territori. Non c'è più spazio per la vita sociale delle donne. Eppure, sono queste stesse donne a cercare soluzioni… a costo di un sovraccarico fisico e mentale.” — intervista tratta da On Our Lands, On Our Bodies - Brasile
Per costruire questa ricerca, abbiamo lavorato insieme al centro di ricerca ARCO e ai team locali di WeWorld in Brasile, Kenya e Tanzania. Abbiamo combinato diversi strumenti: interviste personali, incontri di gruppo, conversazioni con persone esperte e questionari. Ma soprattutto, abbiamo coinvolto direttamente le comunità in ogni fase del lavoro: dalla definizione delle domande fino alla lettura dei risultati. In questo modo, la ricerca non parla delle persone, ma con le persone.
Questo approccio partecipativo ci ha permesso di raccogliere dati concreti e allo stesso tempo situati, che riflettono davvero la realtà dei territori. Vogliamo che da queste conoscenze nascano soluzioni pratiche e sostenibili, costruite insieme a chi vive in prima linea le ingiustizie climatiche, sociali e di genere.
Abbiamo scelto tre Paesi molto diversi tra loro:
- Il Brasile, con le zone semi-aride del Ceará, dove la siccità mette a dura prova la vita quotidiana.
- Il Kenya, dove le regioni aride e semi-aride (ASAL) e quelle costiere subiscono forti variazioni climatiche che minacciano l’agricoltura e la sicurezza alimentare.
- La Tanzania, con gli ecosistemi costieri e insulari di Pemba, sempre più vulnerabili all’innalzamento del mare.
Contesti diversi, ma con sfide comuni: risorse che si esauriscono, infrastrutture fragili, reti sociali che si spezzano e un carico crescente sulle spalle delle donne.
Cosa abbiamo scoperto?
Dalla ricerca emergono punti chiave che accomunano i tre Paesi:
- Il cambiamento climatico amplifica le disuguaglianze. Le crisi ambientali accentuano le differenze economiche e sociali, colpendo più duramente chi ha meno risorse.
- Il genere conta. Le norme sociali influenzano l’accesso alle risorse, ai servizi sanitari e alle decisioni che riguardano la comunità.
- Le donne lavorano di più e riposano di meno. La scarsità d’acqua e di cibo aumenta il carico di lavoro domestico e agricolo, con conseguenze sulla salute fisica e mentale.
- Più povertà, più rischio. La precarietà economica alimenta tensioni in famiglia, violenza di genere e pratiche come i matrimoni precoci.
- Servizi sempre più lontani. Strade e ponti danneggiati rendono difficile raggiungere ospedali e centri sanitari, mettendo a rischio la salute materna e riproduttiva.
- Migrazione e isolamento. Gli uomini migrano in cerca di lavoro, lasciando le donne sole a gestire casa, figli e comunità in condizioni sempre più difficili.
Dalla nostra ricerca in Brasile, Kenya e Tanzania emergono sfide comuni: il cambiamento climatico amplifica le disuguaglianze, aumenta il carico di lavoro delle donne, rende più difficile l’accesso ai servizi sanitari e può aumentare il rischio di violenza di genere. Ogni contesto, però, ha caratteristiche specifiche legate alla geografia, alla cultura e alle dinamiche sociali locali. Al termine dello studio, abbiamo organizzato consultazioni con informatori chiave in tutti e tre i Paesi, durante le quali le comunità hanno condiviso priorità e proposte concrete basate sulla loro conoscenza del territorio. Le raccomandazioni emerse vogliono essere un punto di partenza per sviluppare azioni pratiche e sostenibili, capaci di rafforzare la resilienza delle donne e proteggere i loro diritti, oggi e nel futuro.
Vediamo ora più da vicino cosa è emerso in ciascun Paese.
Donne indigene nell’eco-sistema del Ceará
In Brasile, le comunità indigene del Ceará, uno stato semi-desertico del Nord-Est, vivono in contesti complessi, dove cambiamento climatico, pressioni estrattive, norme patriarcali e povertà si intrecciano. Questi fattori influenzano direttamente la salute sessuale e riproduttiva delle donne, limitando la loro autonomia e aumentando il rischio di violenza di genere. Il degrado ambientale mette a rischio mezzi di sussistenza e sistemi alimentari, ma le donne indigene svolgono un ruolo chiave nella resilienza della comunità, costruendo reti di supporto e partecipando attivamente alla mobilitazione politica.
In Brasile, abbiamo condotto il nostro studio proprio con le comunità indigene dello stato del Ceará. L’indagine ha esplorato come il cambiamento climatico influenzi le relazioni di potere all’interno delle famiglie, in particolare su temi come negoziazione sessuale, pianificazione familiare, matrimoni precoci, violenza di genere e accesso a cure e informazioni. Per farlo, abbiamo usato un approccio qualitativo e partecipativo, raccogliendo informazioni attraverso interviste biografiche, gruppi di discussione e incontri con informatori chiave.
Dalla nostra ricerca, è emerso che:
- Le ragazze stanno avendo il menarca sempre prima, in alcuni casi già a 9 o 10 anni. Questo fenomeno è legato a cambiamenti ambientali e alimentari, come l’esposizione a ormoni e agrofarmaci presenti negli alimenti.
- In diversi contesti, la convivenza precoce con uomini viene scelta come una strategia di sopravvivenza: serve a garantire sicurezza economica o un riparo stabile, e talvolta avviene con il consenso delle famiglie.
- Secondo alcuni informatori chiave, si osserva un aumento di problemi respiratori, malattie della pelle, disturbi gastrointestinali e patologie croniche. Queste condizioni sono spesso connesse al degrado ambientale, all’insicurezza alimentare e alla contaminazione delle fonti d’acqua.
- Le donne di Aldeia Realejo (Crateús) segnalano un incremento di casi di candidosi, infezioni urinarie e dolori renali, che attribuiscono al caldo intenso e al peggioramento della qualità dell’acqua.
- Nelle comunità di Aldeia Olho D’água dos Canutos (Monsenhor Tabosa) e di Aldeia Viração (Tamboril), l’accesso ai servizi sanitari è complicato: sia durante le piogge, a causa delle inondazioni, sia nei periodi di siccità, quando le strade non pavimentate e piene di buche rendono i viaggi rischiosi e rallentano l’arrivo delle cure urgenti.
- Ad Aldeia Mambira (Crateús), intere comunità restano isolate durante le piogge più intense, impedendo alle donne di effettuare visite prenatali o di accedere a servizi medici specializzati.
- Le donne raccontano di vivere un “triplo carico di lavoro”: alle attività domestiche non retribuite si aggiungono il lavoro agricolo o salariato e l’impegno nella vita comunitaria o politica. Questo insieme di responsabilità provoca un forte affaticamento fisico e mentale.
“La mia infanzia e adolescenza non sono esistite; le ho trascorse prendendomi cura dei miei fratelli più piccoli. Ero la maggiore di dieci fratelli e la mia comunità era piena di sofferenza e senza opportunità. La situazione idrica era terribile: dovevamo camminare per ore con i vestiti in testa da lavare, e tornavamo con il collo dolorante. Non c'era acqua corrente, solo pozzi salmastri che ci rendevano la pelle grigia; usavamo l'olio da cucina per idratarci." -intervista tratta da On Our Lands, On Our Bodies – Brasile
Le comunità di Narok, Isiolo e Kwale alle prese con la crisi climatica
In Kenya, la crisi climatica amplifica le disuguaglianze già esistenti e incide profondamente sulla salute sessuale e riproduttiva delle donne. La siccità, le inondazioni e le ondate di calore estremo rendono più difficile l’accesso all’acqua e al cibo, aumentando il carico di lavoro domestico e di cura, spesso non retribuito. Nonostante queste difficoltà, le donne dimostrano grande resilienza e autonomia: si prendono cura della propria salute riproduttiva, partecipano a scambi economici su piccola scala e rafforzano le reti sociali che sostengono la comunità.
La nostra ricerca si è concentrata in tre contee del Kenya:
- Narok: situata nel sud-ovest del Paese, conta oltre 1 milione di abitanti, in gran parte appartenenti alla comunità Masai. L’economia locale si basa sull’allevamento di bestiame, sull’agricoltura e sul turismo.
- Isiolo: si trova nelle aree aride e semi-aride (ASAL) del nord del Paese. Con circa 283mila abitanti, è una delle contee meno popolate ma più etnicamente diversificate. Circa l’80% della popolazione dipende dall’allevamento del bestiame, che rappresenta la principale fonte di reddito.
- Kwale: situata lungo la costa meridionale, conta meno di 870mila abitanti. La sua economia è prevalentemente agricola, con un settore turistico significativo. Tuttavia, il tasso di povertà supera il 70%, molto al di sopra della media nazionale.
In queste tre contee, il nostro studio si è concentrato su come gli effetti del cambiamento climatico incidano sulla salute riproduttiva e materna, soprattutto attraverso la povertà e i problemi legati alle infrastrutture danneggiate. Per capire tutto questo, abbiamo adottato un approccio misto, combinando metodi qualitativi e quantitativi. Abbiamo somministrato questionari strutturati, organizzato gruppi di discussione e condotto interviste con informatori chiave.
Dalla ricerca è emerso che:
- 9 donne su 10 hanno riferito che il cambiamento climatico ha avuto un impatto negativo sull’accesso ai servizi sanitari.
- Circa l’80% ha sperimentato difficoltà durante la gravidanza, dovute soprattutto a stress economico (46%), aumento del lavoro fisico (39%), esposizione al calore estremo (23%) e malattie (21%).
- L’83% delle intervistate ha dichiarato che il cambiamento climatico influisce sulla gestione della salute e dell’igiene mestruale.
- La metà delle donne ha incontrato ostacoli nell’accesso alle visite prenatali e postnatali. Le principali barriere sono: mancanza di mezzi di trasporto (39%); eventi climatici estremi come inondazioni o forti piogge che danneggiano infrastrutture (29%); distanza eccessiva dalle strutture sanitarie (25%)
"Ho osservato diverse aree critiche in cui il cambiamento climatico sta influenzando il benessere riproduttivo delle donne. Una cosa che vedo chiaramente è che le donne ora svolgono lavori molto più pesanti, anche durante la gravidanza. La situazione è aggravata dalla struttura patriarcale della proprietà terriera: sono gli uomini a decidere come utilizzare la terra, anche per piccoli orti. Tante donne sono costrette a lavorare nei campi altrui solo per guadagnare qualcosa." - Intervista tratta da On Our Lands, On Our Bodies – Kenya
La salute materna sull’isola di Pemba
A Pemba, un’isola a circa 56 km dalla costa della Tanzania continentale e parte dell’arcipelago di Zanzibar, le donne percepiscono in modo evidente l’impatto del cambiamento climatico sulla loro vita e sulla salute sessuale e riproduttiva. Per affrontare l’insicurezza alimentare, molte si affidano al sostegno della famiglia, coltivano orti o alghe, oppure partecipano a piccole attività commerciali. Tuttavia, stress economico e conflitti legati alla gestione delle risorse possono aumentare il rischio di violenza di genere, matrimoni forzati e tensioni all’interno delle famiglie.
Abbiamo condotto la nostra ricerca nelle aree di Konde, Micheweni e Majenzi, per indagare come il cambiamento climatico influisca sulla salute materna, in particolare attraverso il suo impatto sulle condizioni socioeconomiche. Per farlo, abbiamo utilizzando un approccio misto che combina strumenti qualitativi e quantitativi. In particolare, sono state realizzate interviste con informatori chiave, interviste biografiche e un questionario strutturato.
Dalla ricerca è emerso che:
- Quasi tutte le donne coinvolte (98%) ritengono che il clima sia cambiato negli ultimi anni.
- Più di 1 su 2 (52%) ha sperimentato ondate di caldo estremo.
- Quasi 6 su 10 (58%) hanno difficoltà nell’approvvigionamento dell’acqua, e 8 su 10 (81%) devono percorrere lunghe distanze per procurarsela, con rischi per la salute e la sicurezza, soprattutto durante la gravidanza.
- Più della metà delle donne (56%) fatica ad accedere a cibo nutriente a causa della crisi alimentare legata al clima, con effetti sulla salute materna e l’allattamento.
- Sebbene il 97% delle donne partorisca in strutture sanitarie, le ostetriche tradizionali continuano a svolgere un ruolo fondamentale durante il travaglio e il postpartum, mostrando un forte legame tra pratiche culturali e bio-mediche.
"In alcuni casi, gli uomini interpretano erroneamente l'assenza delle donne mentre vanno a prendere l'acqua come segno di infedeltà o pigrizia, causando conflitti, sfiducia e sfociando persino in violenza" - Intervista tratta da On Our Lands, On Our Bodies - Tanzania
"Le difficoltà economiche e lo stress causati dai rischi climatici rendono donne e ragazze più vulnerabili alla violenza di genere, inclusi matrimoni forzati, violenza sessuale e domestica. Ad esempio, le discussioni su come il padre, in quanto capofamiglia, possa provvedere alla famiglia spesso degenerano in violenza a causa del peggioramento della situazione economica." - Intervista tratta da On Our Lands, On Our Bodies – Tanzania
Il nostro impegno per la giustizia climatica e ambientale
Noi di WeWorld ci impegniamo per una giustizia climatica femminista, ecologista e decoloniale. Affrontare la crisi climatica significa riconoscerne gli effetti sulla salute, sui diritti e sulle opportunità di donne e ragazze, soprattutto nei paesi a basso reddito, dove gli impatti ambientali si intrecciano con disuguaglianze e vulnerabilità già esistenti.
La nostra attività si basa sia sulla ricerca sia sull’azione concreta. Con l'Atlante Flowing Futures e altri studi, analizziamo il legame tra cambiamento climatico, accesso all’acqua e salute sessuale e riproduttiva. Il nostro ultimo studio “On Our Lands, On Our Bodies” approfondisce gli effetti della crisi climatica sulle comunità rurali e indigene di Brasile, Kenya e Tanzania. Abbiamo inoltre condotto ricerche sulla filiera agroalimentare, per comprendere come il clima influenzi l’agricoltura locale e i mezzi di sussistenza, con particolare attenzione alle donne.
Ma la ricerca da sola non basta: lavoriamo direttamente con le comunità per costruire resilienza e ridurre i rischi climatici. Sosteniamo iniziative di Disaster Risk Reduction (DRR), promuovendo sistemi locali di allerta e piani di emergenza; sviluppiamo pratiche di agroecologia e gestione sostenibile delle risorse naturali; e supportiamo comitati d’acqua guidati da donne, per garantire accesso equo e sostenibile. Organizziamo anche programmi di educazione ambientale, capaci di trasmettere conoscenze pratiche per adattarsi ai cambiamenti climatici.
A livello istituzionale, conduciamo iniziative di advocacy per influenzare le politiche climatiche e sociali, come il lavoro sulla due diligence presso l’Unione Europea, per promuovere responsabilità sociale e tutela dei diritti nelle filiere produttive. Parallelamente, sosteniamo l’attivismo climatico giovanile, valorizzando la partecipazione e la leadership delle nuove generazioni nella costruzione di soluzioni sostenibili.
Mettendo al centro le voci, le esperienze e la leadership delle comunità locali, lavoriamo per un’azione climatica fondata sulla giustizia di genere, capace di integrare resilienza ambientale, accesso alle risorse e diritti delle donne, oggi e nel futuro.
Le persone al centro delle decisioni sul clima
I territori e chi li abita devono avere un ruolo centrale nelle decisioni sul clima. La COP30 può diventare un’occasione concreta per ascoltare queste voci e tradurle in politiche efficaci. Per farlo, servono impegni chiari, risorse adeguate e strumenti che garantiscano equità e protezione dei diritti di tutte le persone, ma in particolare di chi si trova ai margini, come donne e ragazze.
Noi di WeWorld continueremo a lavorare nei contesti più colpiti dalla crisi climatica, con progetti di adattamento, mitigazione gestione delle risorse, agroecologia e riduzione del rischio climatico, mettendo sempre al centro la salute sessuale e riproduttiva. Non si tratta di emergenze isolate: stiamo affrontando problemi strutturali che richiedono soluzioni durature.
In un mondo in cui crisi climatiche, disuguaglianze e violazioni dei diritti si intrecciano, il vero obiettivo non è solo affrontare emergenze isolate, ma garantire alle attuali e alle prossime generazioni e, in particolare, a coloro che si trovano ai margini il diritto a un futuro sicuro e dignitoso. La giustizia climatica, di genere e sociale non può essere separata: solo riconoscendo l’interconnessione tra ambiente, diritti e equità possiamo immaginare un domani in cui tutte le persone possano vivere con libertà, sicurezza e opportunità reali.