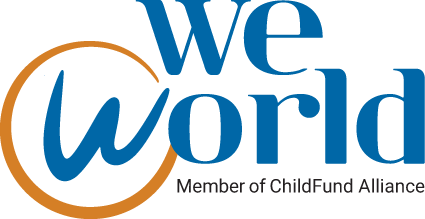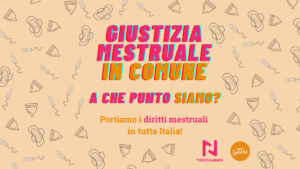Nel nostro paese, serve ripensare l’educazione maschile per una scuola davvero equa.
A scuola, i maschi faticano più delle ragazze: hanno voti medi più bassi, più richiami disciplinari e più casi di abbandono. Eppure, si continua a parlare di questi dati come se fossero semplici "comportamenti problematici", non il segno di qualcosa di più profondo: un sistema educativo che non si interroga abbastanza su come educa, e a chi parla. Non possiamo costruire una scuola davvero equa se non iniziamo a chiederci: che educazione stanno ricevendo i maschi? Cosa imparano sulla forza, sulla vulnerabilità, sulla competizione, sul rispetto? E cosa succede quando, per loro, l’unico modo per “funzionare” è adattarsi o sparire?
La scuola italiana è a misura di tutte e tutti?
Nel nostro paese, la scuola non è (ancora) un luogo a misura di tutte e tutti. Tra i banchi continuano a ripetersi vecchi schemi che creano e rafforzano le disuguaglianze tra ragazzi e ragazze, invece di superarle. Questo succede ogni giorno, nei programmi, nei libri di testo, nei modi di parlare, nelle aspettative su come devono comportarsi, in quello che viene premiato o punito, in come si ascoltano (o non si ascoltano) le loro storie.
Le ragazze spesso vanno meglio a scuola, ma solo se si adattano a essere tranquille, responsabili, e cooperative. Devono “stare al loro posto” e mostrarsi più mature della loro età. Ai ragazzi, invece, è concesso sbagliare di più, ma ricevono meno attenzione e meno aiuto per capire e gestire emozioni e relazioni (Duckworth et al., 2006; Matthews et al., 2009; Voyer et al., 2014; Gustaven, 2017; Ogden et al., 2021).
Quando sono troppo esuberanti vengono puniti, ma nessuno cerca di capire cosa succede davvero. Le difficoltà di apprendimento restano spesso invisibili e diventano problemi grandi. Così la scuola esclude chi non rientra nei modelli tradizionali, sia per genere, sia per origine sociale, culturale o linguistica.
Se vogliamo parlare davvero di giustizia educativa e parità di opportunità a scuola, dobbiamo ammettere che il sistema attuale non riconosce la varietà di modi in cui si impara, di identità e bisogni. E che questo colpisce ragazzi e ragazze in modo diverso: con le ragazze che si caricano troppo e i ragazzi che vengono lasciati indietro senza che nessuno se ne accorga. Non è una gara a chi soffre di più, ma è importante capire come la scuola possa aumentare le disuguaglianze invece di ridurle. Per questo serve un’educazione attenta al genere, che non si fermi a dire “siamo uguali” ma cambi davvero le pratiche, i linguaggi, i contenuti e i rapporti tra le persone.
Parlano gli e le adolescenti: i dati dalla nostra ricerca
Se la scuola fatica a riconoscere e valorizzare la diversità dei bisogni e delle identità, questo si riflette anche nel modo in cui maschi e femmine gestiscono le proprie emozioni nel quotidiano. Proprio per questo, tra gennaio e febbraio 2025, nell’ambito del progetto educativo “Exponi le tue idee!”, dedicato quest’anno alla parità di genere, abbiamo coinvolto in una consultazione nazionale 319 ragazze e ragazzi di età compresa tra 13 e 19 anni, provenienti da 26 scuole secondarie italiane. L’obiettivo era esplorare cosa significhi crescere oggi, tra emozioni, corpo, relazioni e salute sessuale.
Abbiamo chiesto quali emozioni si sentano liberi e libere di esprimere apertamente e quali, invece, imparino a nascondere, oltre a come cambia il rapporto con il sé e con le altre persone. Le risposte mostrano due esperienze molto diverse: le ragazze, pur vivendo un maggiore disagio emotivo, tendono a chiedere aiuto più facilmente; i ragazzi, invece, risultano più restii a parlare delle proprie fragilità, restando spesso in disparte rispetto ai discorsi sul benessere psicologico.
Le emozioni “invisibili” dei maschi
Le difficoltà vissute dai maschi non nascono dall’indifferenza, ma da un modo di costruire l’identità maschile che si radica fin dall’infanzia. Molti ragazzi imparano presto quali emozioni possono mostrare e quali devono gestire da soli, in silenzio. Rabbia, tristezza e paura diventano spesso autocontrollo o chiusura emotiva, come confermano i dati raccolti:
- di fronte alla rabbia, quasi 2 ragazzi su 3 (63,3%) dichiarano di calmarsi da soli, mentre solo 1 su 4 (26,6%) ne parla con una persona di fiducia;
- di fronte alla tristezza, oltre la metà sceglie di distrarsi, e solo 1 su 7 (14,1%) si confida con qualcuno.
Anche la gestione della salute mentale risente di questa tendenza al silenzio: poco più di 1 ragazzo su 2 (53,1%) si rivolgerebbe a un o una professionista in caso di bisogno, contro più di 2 ragazze su 3 (69,7%). Un terzo dei maschi prova disagio all’idea stessa di chiedere aiuto, nonostante il 78,1% riconosca l’importanza della salute mentale.
Anche la scuola riflette questo malessere. Emozioni negative come noia (92,9%), frustrazione (79,7%) e ansia (84,4%) sono diffuse tra tutti gli studenti, ma i ragazzi le vivono spesso in silenzio, senza strumenti per riconoscerle o comunicarle. Solo il 2,3% - associa alla scuola un’emozione positiva come la felicità, un segnale chiaro di disagio diffuso. Nei ragazzi, questo si traduce spesso in isolamento emotivo e difficoltà a chiedere aiuto.
Il messaggio che arriva dagli studenti è chiaro: l’83% chiede un cambiamento, con più spazi di ascolto e attenzione all’educazione emotiva. Questo bisogno è condiviso da entrambi i generi, ma per i ragazzi assume un valore particolare: desiderano sentirsi accolti e poter parlare delle proprie difficoltà senza sentirsi giudicati o “fuori ruolo”.
Orientarsi tra le maschilità
Questa distanza tra consapevolezza e comportamento non nasce per caso: è il risultato di un processo spesso invisibile, quello della socializzazione di genere. Fin da piccoli, molti ragazzi imparano che per “essere maschi” bisogna mostrarsi forti, indipendenti, controllati, competitivi. Emozioni come la tristezza o la paura devono essere tenute a bada o nascoste. E chiedere aiuto può sembrare, agli occhi di molti, un segno di debolezza.
Ma la maschilità non è un’esperienza unica o fissa: esistono maschilità plurali, modi diversi e legittimi di vivere la propria identità di genere (Connell, 1993). Per maschilità si intende l’insieme di pratiche, atteggiamenti, rappresentazioni sociali e culturali che vengono associate al “diventare” o “essere” uomo in un determinato contesto storico e sociale: non quindi una qualità naturale o biologica, ma una costruzione sociale che varia nel tempo e nello spazio. Tuttavia, accanto a questa pluralità, continua a dominare un modello culturale — quello della maschilità egemonica — che stabilisce cosa “dovrebbe” essere un uomo: sicuro, forte, distaccato, capace di cavarsela da solo. Questo modello, spesso dato per scontato, esercita una pressione costante e profonda, anche su chi non vi si riconosce.
Molti ragazzi si sentono spinti ad adottare atteggiamenti che non rispecchiano le proprie inclinazioni, pur di essere accettati e riconosciuti. In questa tensione tra ciò che si è e ciò che si dovrebbe essere si genera spesso una crisi identitaria, che raramente viene colta dalle persone adulte, dalle figure educative e, in generale, dai contesti che i ragazzi frequentano.
Questa crisi non è solo personale: ha ricadute evidenti anche sull’esperienza scolastica. Il bisogno di aderire a un certo ideale di maschilità può portare a evitare comportamenti considerati “non maschili”, come chiedere aiuto, impegnarsi apertamente nello studio, mostrarsi insicuri o fragili. In molti casi, la scuola — se non riconosce e decostruisce questi codici — finisce per rafforzarli, premiando inconsapevolmente chi si adatta meglio a certi ruoli, e lasciando indietro chi ne resta schiacciato (Kagesten et al., 2016).
Il risultato è visibile: disconnessione emotiva, calo di partecipazione, difficoltà relazionali, peggioramento dei risultati, fino all’abbandono scolastico. La pressione ad aderire a un modello di maschilità idealizzata non solo ostacola la libertà di espressione, ma limita l’accesso stesso all’apprendimento. Quando un ragazzo si sente costretto a recitare un ruolo, la scuola smette di essere un luogo di crescita e diventa un contesto in cui proteggersi, resistere o, in alcuni casi, sparire.
Eppure, questo disagio resta spesso invisibile, anche perché mancano strumenti e riferimenti per leggere le maschilità in modo critico e plurale. A scuola, troppo spesso, non si adottano approcci realmente sensibili al genere, e il genere stesso viene spesso associato solo all’esperienza delle ragazze. Ma anche i ragazzi appartengono a un genere, quello maschile: il modo in cui vivono e interpretano la propria identità è profondamente influenzato da aspettative sociali che meritano di essere riconosciute, interrogate e messe in discussione. Finché questo non accade, il loro malessere rischia di essere frainteso, ridotto a “disinteresse” o “problema comportamentale”, senza coglierne le radici profonde.
Per capire davvero l’impatto di questi modelli sui percorsi educativi, dobbiamo guardare più da vicino come le aspettative legate al genere influenzano il modo in cui i ragazzi vivono la scuola, affrontano le difficoltà e costruiscono (o interrompono) il proprio percorso scolastico.
Andare a scuola, ma senza imparare: la dispersione implicita
È forse la forma più sottile e trascurata di disuguaglianza scolastica. Si parla di dispersione implicita quando studentesse e studenti, pur restando dentro il sistema, non raggiungono le competenze minime richieste. In pratica: vanno avanti senza acquisire strumenti fondamentali per il lavoro, la cittadinanza, la vita. I dati Invalsi 2025 mostrano che le difficoltà iniziano già nella scuola primaria, colpendo bambine e bambini in modo diverso, e si cronicizzano andando avanti col tempo:
- In italiano, i bambini — soprattutto con background migratorio o provenienti da contesti svantaggiati — faticano più delle bambine fin dalla seconda elementare. La competenza in lettura è fondamentale per il futuro successo scolastico, ma già dopo soli due anni di scolarizzazione le bambine hanno un vantaggio di 2,5 punti rispetto ai bambini. Al termine del ciclo di scuola superiore, questo risultato si consolida e le ragazze ottengono risultati superiori di 4 punti rispetto ai ragazzi.
- In matematica, lo scenario si inverte: già in seconda, le bambine sono indietro di 3,6 punti rispetto ai maschi; in quinta superiore, il divario sale a 6,8 punti.
Questa polarizzazione di genere non è “naturale”: maschi e femmine hanno infatti gli stessi livelli di intelligenza. A cambiare non è la capacità cognitiva, ma i tempi e le modalità di apprendimento, legati a diversi ritmi di sviluppo. Le bambine tendono a maturare prima le cosiddette competenze “non cognitive” come organizzazione, autocontrollo e attenzione. I bambini, invece, sviluppano queste abilità più tardi, ma si confrontano comunque con un sistema educativo che richiede disciplina e valorizza proprio le competenze che le bambine acquisiscono prima (Yung et al., 2019; Nebli et al., 2019).
Queste differenze biologiche, però, non si traducono in livelli di maggiore o minore intelligenza. Piuttosto, dovrebbero spingerci a riflettere sul fatto che ogni modello educativo è il prodotto di precisi contesti storici, economici e culturali. Ed è qui che entra in gioco un paradosso: se i livelli di intelligenza sono equivalenti e l’impostazione scolastica sembra favorire le bambine, perché in media ottengono risultati peggiori in matematica? La spiegazione non sta (solo) nella biologia, ma nell’intreccio tra sviluppo individuale e condizionamenti sociali: stereotipi e aspettative di genere che, fin dai primi anni di scuola, influenzano scelte, autostima e performance.
Anche gli e le insegnanti, spesso inconsapevolmente, tendono a interpretare le difficoltà in modo diverso: un errore in matematica fatto da una ragazza può sembrare conferma di una "non predisposizione", mentre la fatica nella lettura da parte di un ragazzo viene vista come “normale” (Ogden et al., 2021; Gajda et al., 2022). Questi bias possono condizionare valutazioni, incoraggiamenti, aspettative e finire per attivare profezie autoavveranti. Così, le bambine si convincono di essere più portate per le materie umanistiche, i bambini per quelle tecnico-scientifiche.
Tuttavia, mentre l’attenzione è giustamente concentrata sulle difficoltà delle bambine nelle STEM e sulle cause della loro esclusione, rimane ancora poco esplorato un altro fenomeno altrettanto importante e sottile: il ritardo nelle competenze di lettura e, più in generale, nelle materie umanistiche che riguarda i maschi. Non essendoci un’adeguata riflessione sulla costruzione delle maschilità e sui suoi impatti, si rischia di lasciare molti ragazzi indietro, invisibili nelle statistiche ma in grave svantaggio rispetto alle competenze fondamentali per la vita, il lavoro e la cittadinanza.
Le conseguenze sono profonde: le scelte scolastiche e professionali di ragazze e ragazzi finiscono per riflettere più stereotipi culturali che reali inclinazioni, consolidando disuguaglianze di genere che si trascinano ben oltre la scuola.
Leggi il nostro report We Stem for our future.
Lasciare la scuola: la dispersione esplicita
L’abbandono scolastico è la forma più visibile di dispersione educativa: riguarda chi lascia la scuola prima del diploma. In Italia, il fenomeno è in calo, ma resta rilevante, soprattutto tra i maschi e nelle aree più marginalizzate.
- Nel 2024, secondo ISTAT, il 9,8% ha abbandonato gli studi (era l’10,5% nel 2023). Sebbene questo dato si avvicini all’obiettivo UE del 9%, la media generale nasconde profonde disuguaglianze.
- Le differenze territoriali sono marcate: Sardegna (14,5%) e Sicilia (15,2%) superano di gran lunga le regioni del Nord come Emilia-Romagna e Lombardia, sotto il 9%.
- La differenza di genere è netta: abbandona il 12,2% dei ragazzi, contro il 7,1% delle ragazze.
- Il rischio di abbandono aumenta anche per chi ha un background migratorio, arrivando al 26,8%, quasi tre volte la media nazionale.
Tuttavia, non è tanto la cittadinanza a fare la differenza, quanto fattori come il ritardo scolastico, le assenze frequenti e la scelta degli istituti professionali, frequentati soprattutto da ragazzi. Proprio in questi percorsi si registrano i tassi più alti di abbandono. Spesso i ragazzi si orientano subito verso il lavoro, quando riescono a trovarlo, lasciando la scuola prima di completare gli studi.
Le cause sono molte: difficoltà familiari, una scuola che sembra distante dalla vita reale, e la mancanza di un’educazione sensibile al genere. Per molti ragazzi questo si traduce in un senso di inadeguatezza e allontanamento dalla scuola. Questo distacco ha effetti concreti anche fuori dall’aula: aumenta il rischio di sfruttamento sul lavoro, di coinvolgimento in attività illegali o di isolamento sociale. In alcuni casi, può portare a forme estreme di ritiro, come l’hikikomori (persone, soprattutto giovani, che scelgono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi di tempo, spesso restando isolate nella propria stanza o in casa), un segnale di disagio che spesso resta invisibile (Pozza et al., 2019).
Leggi il nostro report Diritti ai margini.
Cosa succede quando si diventa “grandi”?
L’uscita dalla scuola non coincide sempre con l’ingresso nella vita adulta. Per molti e molte giovani rappresenta l’inizio di una lunga fase di stallo: quella dei NEET (Not in Education, Employment or Training). Nel 2024, stando ai dati di ISTAT, in Italia erano più di 1 su 7 (15,2%) tra le persone tra i 15 e i 29 anni. Una quota superiore alla media UE dell’11%, e il secondo tasso più alto in Europa dopo la Romania.
Le traiettorie NEET sono diverse per genere:
- I ragazzi escono prima dal sistema, spesso a causa di abbandoni scolastici e difficoltà a reinserirsi nella formazione o nel lavoro.
- Le ragazze diventano più inattive dopo i 25 anni, spesso per carichi familiari e lavoro di cura non retribuito.
Nel 2024, le giovani donne NEET erano il 16,6% tra le persone tra i 15 e i 29 anni, rispetto al 13,8% dei giovani uomini. Il 20,6% delle donne tra chi è NEET dichiara di non cercare lavoro perché impegnata nella cura della famiglia. Il 2,4% degli uomini fornisce la stessa motivazione, dando già una prima evidenza delle divergenze di genere che caratterizzano il fenomeno. Paradossalmente, le NEET donne sono in media più istruite dei coetanei maschi. Tra i giovani uomini che non studiano e non lavorano è molto diffusa la disoccupazione di lunga durata: circa il 19% dichiara di cercare lavoro da tempo senza successo.
Questa situazione non ha solo effetti economici, ma anche psicologici. Restare a lungo senza un impiego e senza prospettive concrete può portare a scoraggiamento, perdita di fiducia in sé stessi e, nei casi più gravi, isolamento sociale.
Ad ogni modo, alla radice del fenomeno NEET sembra esserci un sistema scolastico che non funziona come ascensore sociale, ma come selettore rigido:
- Per i ragazzi, il fallimento scolastico spesso li spinge fuori dal sistema troppo presto.
- Per le ragazze, anche il successo può tradursi in marginalità, a causa delle disuguaglianze culturali e del lavoro di cura.
Anche tra chi non abbandona gli studi, le disuguaglianze permangono. Il divario educativo tra maschi e femmine si riflette nel passaggio all’università e, più tardi, nel mondo del lavoro. Nel 2024, secondo AlmaLaurea, solo il 25% degli uomini tra 25 e 34 anni aveva un titolo universitario, contro il 38,5% delle donne. Le donne si laureano prima e con voti migliori, ma poi il mercato del lavoro le penalizza.
L’Italia resta tra i Paesi europei con il tasso di occupazione femminile più basso (20 punti percentuali inferiore rispetto a quello maschile), e con una forte femminilizzazione delle professioni meno pagate. In sintesi: la scuola e il lavoro parlano due lingue diverse sul genere. Prima penalizzano i ragazzi, poi le ragazze.
La scuola non è neutra: genere, regole e aspettative
Molti studenti e molte studentesse oggi vivono la scuola come un luogo difficile, a volte distante, in cui è facile sentirsi fuori posto. Non si tratta solo di disinteresse o “scarsa motivazione”, come spesso si dice. In molti casi, le difficoltà scolastiche sono il sintomo di un sistema che non riesce a riconoscere davvero chi ha davanti. La scuola, infatti, non è un ambiente neutro: riproduce, spesso senza rendersene conto, aspettative, ruoli e disuguaglianze legate al genere.
Non è una questione di “cervello maschile” o “cervello femminile”, ma è vero che fin da piccoli e piccole veniamo educati in modo diverso: ai ragazzi si chiede di essere forti, attivi, indipendenti; alle ragazze di essere tranquille, responsabili, disponibili. Questi modelli, interiorizzati presto, influenzano anche il modo in cui ciascuno si avvicina all’apprendimento, si comporta in classe, si percepisce rispetto al giudizio delle persone adulte.
Il problema è che la scuola continua spesso a premiare un solo tipo di comportamento e apprendimento: quello più conforme, ordinato, silenzioso. Tutto il resto, che si tratti di agitazione, disorganizzazione, disinteresse, o anche semplice originalità, viene letto come un problema da correggere. Ma cosa succede se, invece di giudicare chi non si adatta, proviamo a chiederci perché certe modalità non trovano spazio nella scuola? E che ruolo ha il genere in tutto questo?
- Aspettative fuori e dentro la scuola non si incontrano: Fin da bambini, i ragazzi sono spesso incoraggiati a muoversi, a esplorare, a essere fisici; invece, a scuola devono stare fermi, ascoltare e obbedire. Questo scontro tra il modo in cui vivono fuori e quello che viene chiesto dentro l’aula rende la scuola frustrante, soprattutto per molti maschi (Norris et al., 2015). Le ragazze, invece, imparano presto a essere “brave bambine”: attente, ordinate, responsabili. Questo sembra un vantaggio, ma può diventare una gabbia invisibile che le spinge a non sbagliare o disturbare mai, una forma di iperadattamento che limita la loro libertà (Bian et al., 2017). In entrambi i casi, la scuola premia chi si adegua a un modello unico, lasciando fuori chi si esprime in modi diversi.
- Scuole troppo rigide e normate: Gli ambienti scolastici molto rigidi e pieni di regole spesso non vanno bene per chi ha uno stile di apprendimento più dinamico, orientato all’azione, più frequente tra i ragazzi. Ancora una volta, questo non è un fatto naturale, ma culturale, e la scuola spesso mantiene queste differenze invece di provare a superarle (Brozo et al., 2014; Jackman et al., 2019). Allo stesso tempo, questa rigidità mette pressione anche sulle ragazze, costringendole a reprimere i loro bisogni o dubbi che non si adattano alle aspettative. Il messaggio è chiaro: devi essere il “buon studente” o la “brava studentessa”, niente vie di mezzo o espressioni diverse.
- Didattica troppo teorica e frontale: Le lezioni che puntano solo alla trasmissione di nozioni, con poca interazione o attività pratica, mettono in difficoltà chi impara meglio con esperienze concrete, movimento o lavoro di gruppo — modalità più comuni tra molti ragazzi, ma non solo. Anche le ragazze soffrono quando la scuola non lascia spazio a sperimentare senza paura del giudizio o del perfezionismo. Una didattica così limita il potenziale di tutti e tutte, anche di chi sembra “funzionare” bene nel sistema.
- Regole e punizioni che colpiscono soprattutto i ragazzi: Quando studenti e studentesse non si adattano al modello richiesto, la scuola risponde spesso con punizioni. I ragazzi sono quelli che più spesso vengono richiamati, sospesi o bocciati. Nel 2022-23, per esempio, l’1,7% dei ragazzi non ha superato la prima media, contro l’1,4% delle ragazze. Le ragazze, invece, ottengono tassi di promozione più alti: quasi il 99% in seconda media, contro il 98,3% dei ragazzi.
- “I maschi sono così”: un pregiudizio che allontana i ragazzi dalla scuola: Spesso le punizioni non risolvono i problemi di comportamento, ma aumentano il distacco soprattutto di molti ragazzi, che così rischiano di abbandonare la scuola presto. Questo succede anche perché molti e molte insegnanti credono che i ragazzi siano meno motivati o meno responsabili delle ragazze (Watson et al., 2010; Riley, 2014; Yu et al., 2020). Così si spiega l’insuccesso solo con la mancanza di impegno o organizzazione dei singoli, senza guardare alle difficoltà della scuola o alle sue modalità di insegnamento. È quello che si chiama “modello del deficit”: si colpevolizzano gli studenti invece di cambiare ciò che non funziona.
- Pochi modelli maschili a scuola e l’importanza di nuove maschilità: Un altro problema è la scarsità di insegnanti uomini, soprattutto nella scuola primaria, un momento cruciale in cui inizia a formarsi il senso del sé. Nel 2024, su circa 709 mila docenti, quasi 586 mila erano donne: quasi il 99% nelle scuole d’infanzia e oltre il 96% nelle primarie. Anche alle medie e superiori la maggioranza sono donne. Questa mancanza di modelli maschili può pesare, specialmente per ragazzi che cercano punti di riferimento fuori casa, in famiglie con difficoltà economiche o background migratorio. Ma ci sono studi recenti (Goldie, 2021; Jin et al., 2021) che dimostrano come ambienti scolastici più inclusivi, con insegnanti preparati a riconoscere e utilizzare approcci sensibili al genere, aiutino a migliorare la motivazione e i risultati dei ragazzi. Così come la presenza di modelli femminili nel lavoro sfida gli stereotipi, è importante promuovere forme di maschilità positiva, alternative alla “maschilità egemonica” — cioè il modello dominante che mantiene le disuguaglianze di genere e i privilegi di pochi (Connell, 1993). Questi nuovi modelli possono contaminare anche settori tradizionalmente femminili, come l’insegnamento, aprendo nuove strade di identità ed espressione per i ragazzi e contribuendo a una scuola più giusta, aperta e libera da stereotipi.
Il nostro impegno per una pedagogia di genere
Come WeWorld, lavoriamo ogni giorno per costruire ambienti educativi che siano davvero a misura di tutti e tutte: spazi dove bambini e bambine, ragazzi e ragazze possano sentirsi riconosciuti, rispettati e liberi di crescere al di là di ruoli imposti e aspettative stereotipate.
La nostra pedagogia di genere è:
- Critica, perché non accetta come “naturali” le regole che escludono o zittiscono chi non si conforma.
- Decoloniale, perché mette in discussione l’universalità di modelli educativi eurocentrici.
- Non binaria, perché riconosce che l’identità di genere è fluida, relazionale e aperta a molteplici possibilità.
Tutto questo riguarda anche — e soprattutto — i maschi. Perché troppo spesso a scuola i ragazzi vengono lasciati indietro senza che nessuno se ne accorga, fraintesi nelle loro emozioni, sanzionati nei comportamenti, spinti dentro modelli di maschilità che non hanno scelto. Hanno meno occasioni per esplorare la cura, per esprimere dubbi, per mostrarsi fragili senza essere puniti o ridicolizzati. E così, quello che potrebbe essere uno spazio di libertà diventa un luogo in cui si impara a reprimere, a irrigidirsi, a distaccarsi.
Quando un ragazzo abbraccia una docente per ringraziarla e quel gesto viene letto come “inappropriato”, mentre lo stesso fatto da una bambina passa inosservato, non è solo un episodio. È il sintomo di un problema più profondo: la scuola partecipa alla sessualizzazione precoce del corpo maschile, negando ai ragazzi la possibilità di vivere pienamente la propria dimensione affettiva e relazionale.
Ecco perché non basta “includere anche i maschi”: serve un lavoro attento, continuo e trasformativo per liberarli dai modelli che li ingabbiano e offrire loro nuove possibilità di essere. Non si tratta di proteggere una “maschilità in crisi”, ma di mettere in discussione quella dominante — quella che premia il controllo, la competizione, la distanza emotiva — e costruire insieme modelli alternativi di maschilità più aperti, plurali e affettivi.
È nella scuola che questa trasformazione può, e deve, cominciare. Per questo chiediamo che l’educazione all’affettività e alla sessualità diventi parte integrante dei curricula scolastici: non solo per trasmettere informazioni, ma per crescere persone più libere, consapevoli e capaci di relazione. Perché la libertà emotiva, la possibilità di cura, la piena espressione di sé — anche per i maschi — non devono essere eccezioni, ma diritti.