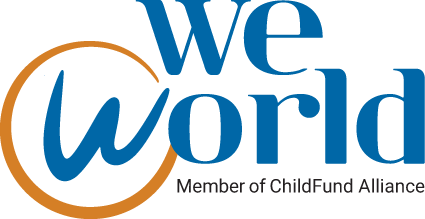Troppe disuguaglianze e nessun supporto estivo: riformare il tempo scuola è una necessità educativa e sociale, non un capriccio.
L’estate italiana è troppo lunga. E no, non è solo una questione di vacanze, ma di equità, diritti, benessere e futuro. Oggi la scuola italiana si ferma per 13-14 settimane ogni anno, uno dei periodi di interruzione più lunghi d’Europa. Questo non è più sostenibile: né per il diritto all’educazione di bambini e bambine, che perdono competenze e opportunità, né per le famiglie, spesso lasciate sole nella gestione del tempo estivo.
Da qui nasce la campagna “Ristudiamo il calendario” – una serie di proposte per una scuola più giusta, aperta e a misura di tutte e tutti - che da anni portiamo avanti insieme a Mammadimerda – progetto di divulgazione dissacrante e ironico sulla maternità fondato da Francesca Fiore e Sarah Malnerich.
Ecco una guida per capire di cosa stiamo parlando e perché cambiare il tempo scuola non è un capriccio, ma una necessità.
Perché parliamo di riforma del tempo scuola in Italia?
Il calendario scolastico italiano prevede circa 200 giorni di lezione, con una lunga pausa estiva di quasi tre mesi e brevi interruzioni per Natale e Pasqua. Questo modello, pensato più di un secolo fa in un’Italia ancora prevalentemente rurale, rispondeva a un’esigenza ben precisa: i bambini e le bambine dovevano aiutare la propria famiglia nei lavori agricoli durante l’estate. Oggi quella necessità non c’è più, ma il calendario è rimasto praticamente invariato, non adattandosi ai bisogni di famiglie, studenti e studentesse e società contemporanei.
Nel resto d’Europa, i calendari scolastici variano parecchio, con una media di circa 180 giorni di scuola e vacanze distribuite in modo differente:
- Regno Unito: tre pause principali (Natale, Pasqua ed estate di circa 6 settimane) più le “half-term breaks”, cioè pause di una settimana a ogni trimestre;
- Spagna: calendario simile all’Italia, con vacanze estive, di Natale e Pasqua, ma con inizio e fine anno scolastico leggermente più flessibili (tra il 1° e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno);
- Francia: vacanze estive che iniziano tra il 16 giugno e il 13 luglio, a seconda della zona, e pause più distribuite durante l’anno;
- Germania: vacanze estive di circa sei settimane, con variazioni tra i diversi stati federati.
Oggi, in Italia l’assenza di pause intermedie oltre a quelle festive contribuisce a generare stress e disuguaglianze, soprattutto per chi vive in contesti più svantaggiati, che vedono ridotte le occasioni di socialità e di supporto educativo. Senza momenti di riposo, infatti, la stanchezza si accumula, cresce la pressione e diventa più facile sentirsi sopraffatti.
Una ricerca di Unisona-live e Unicef mostra che il 75% degli studenti e delle studentesse si sente "sempre" o "spesso" stressato per la scuola, il 44% prova insicurezza per la forte competizione e il 17% fatica a imparare proprio a causa di questo clima.
Ripensare il tempo scuola significa rendere la scuola più vicina ai diritti di bambini, bambine e adolescenti e ai bisogni reali delle famiglie, con un’offerta più continua e inclusiva e orientata a ridurre le disparità.
In che cosa consiste la nostra proposta di riforma del tempo scuola?
La nostra proposta di rimodulazione del tempo scuola si basa su due punti principali:
1. UN NUOVO CALENDARIO SCOLASTICO
La proposta non è fare lezione anche d’estate, ma ripensare la distribuzione del tempo scuola: più pause brevi e regolari durante l’anno (ad esempio una settimana in autunno e primavera, o ogni 6-8 settimane), riducendo la lunga interruzione estiva.
L’idea non è ridurre i giorni di scuola, che rimarrebbero 200 come previsto dalla legge, ma distribuirli in modo più equilibrato per favorire il benessere di studenti, studentesse e famiglie. Durante le nuove pause dall’attività didattica – così come nei mesi estivi – le scuole resterebbero aperte, garantendo una continuità educativa attraverso attività diverse da quelle tradizionali. Non si parlerebbe di compiti o interrogazioni, ma di laboratori, sport, lettura, teatro, arte, scienza e gioco: esperienze pensate per arricchire, non valutare. Si tratterebbe di percorsi educativi non obbligatori, gratuiti o accessibili, in grado di sostenere bambini, bambine e adolescenti nel loro sviluppo, anche fuori dalla didattica formale.
Queste attività sarebbero realizzate in collaborazione con il Terzo Settore, figure educative, operatori e operatrici culturali e associazioni del territorio grazie all’attivazione di Patti educativi di comunità. La scuola diventerebbe così un presidio educativo stabile, aperto alla comunità, anche fuori dai tempi della didattica tradizionale.
Continuità educativa, non più solo didattica
L’obiettivo non è aumentare le ore di lezione, ma evitare di chiudere la scuola per mesi interi, lasciando indietro chi ha meno risorse. Una scuola aperta tutto l’anno non sostituisce la famiglia, ma la sostiene. Non obbliga, ma offre opportunità e riduce le disuguaglianze tra chi può permettersi esperienze educative extra e chi no.
Ma perché è così importante garantire continuità educativa?
- PER CONTRASTARE IL SUMMER LEARNING LOSS: Durante la lunga pausa estiva, molti studenti e studentesse perdono parte delle competenze acquisite durante l’anno: è il cosiddetto summer learning loss, una regressione nei livelli di apprendimento causata dall’interruzione dell’offerta educativa.
Uno studio condotto negli Stati Uniti su quasi 40 ricerche ha mostrato che, in media, gli e le studenti perdono fino a un mese di apprendimento durante l’estate, e che questa perdita varia in base a fattori come età, materia e soprattutto contesto socioeconomico. Per un o una dodicenne di classe media che vive in un quartiere ben servito e ha genitori laureati, l’estate può diventare un’opportunità di crescita: viaggi, musei, corsi, stimoli culturali. Per un coetaneo o una coetanea che risiede in un contesto più fragile, invece, è come se il processo di apprendimento si fermasse.
Senza risorse, esperienze, e occasioni per crescere, socializzare e imparare, il divario che si apre a settembre rischia di non colmarsi più e generare povertà educativa.
- PER RIDURRE LA POVERTÀ EDUCATIVA: la povertà educativa non si riduce alla semplice mancanza di scuola, ma nasce dall’assenza di un intero contesto fatto di libri, sport, arte, musica, socialità e dialogo. Quando la scuola chiude, in molte realtà si spegne l’unico spazio dove questi stimoli arrivano, e chi parte già svantaggiato riceve meno, impara meno e finisce per sentirsi meno capace.
Questo svantaggio si accumula nel tempo: molti studenti e molte studentesse, soprattutto chi proviene da contesti socioeconomici più marginalizzati, non riescono a consolidare le competenze di base durante l’anno, una forma di dispersione implicita che è a tutti gli effetti una manifestazione di povertà educativa.
In Italia, il 40% degli studenti e delle studentesse non raggiunge i livelli minimi in italiano al termine della scuola primaria, e quasi la metà non li raggiunge in matematica al termine della secondaria di secondo grado. La pausa estiva, priva di stimoli educativi di qualità, aggrava ulteriormente questo divario.
Per molti e molte minori in condizioni di disagio, l’estate non è tempo di crescita ma di isolamento: famiglie senza risorse economiche e sociali non possono garantire esperienze formative o ricreative che incoraggiano l’apprendimento anche d’estate. Un milione e trecentomila minori vivono in povertà assoluta e oltre il 28% delle famiglie con figli non può permettersi nemmeno una settimana di vacanza, con punte del 37% tra le famiglie monogenitoriali. In questo contesto, la povertà educativa diventa un circolo vizioso che mina le possibilità di successo scolastico e di sviluppo personale.
- PER TENERE APERTO IL “RUBINETTO” DELL’EQUITÀ: la “teoria del rubinetto”, elaborata da Entwisle, Alexander e Olson, spiega come durante l’anno scolastico la scuola eroghi risorse educative in modo relativamente equo, ma nelle lunghe pause, come quella estiva, questo flusso si interrompa.
Come abbiamo visto, in quei mesi, non tutti gli studenti e le studentesse hanno uguale accesso a esperienze culturali, educative o ricreative: chi proviene da famiglie con più risorse continua a imparare, mentre chi vive in contesti svantaggiati resta indietro, accentuando le disuguaglianze.
La perdita di apprendimento estiva non riguarda solo le competenze scolastiche formali, ma anche l’arricchimento personale che deriva da attività extrascolastiche. Per questo il dibattito sul calendario scolastico dovrebbe essere inserito in un contesto più ampio, che coinvolga la comunità e miri a garantire un’estate di crescita educativa per tutti e tutte, riconoscendo nell’apertura costante e garantita della scuola un fondamentale “rubinetto” di equità.
2. UN VERO TEMPO PIENO
Il tempo pieno, introdotto in Italia nel 1971, rappresenta un modello educativo ormai consolidato, ma ancora non accessibile ovunque allo stesso modo. Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione, nel 2025/26 solo il 51,2% degli studenti e delle studentesse frequenterà una scuola a tempo pieno, con forti disparità tra le regioni.
Nel Lazio la percentuale raggiunge il 70,8%, seguita dall’Emilia-Romagna con il 65,1% e dal Piemonte con il 64,1%.
Al Sud, invece, le cifre si abbassano sensibilmente: in Calabria il tempo pieno coinvolge solo il 36,4% degli alunni e delle alunne, in Puglia il 31,7% e in Sicilia appena il 20,7%. Il divario tra Nord e Sud è evidente.
A influenzare questi dati non sono solo fattori culturali o sociali, ma soprattutto la reale disponibilità di strutture scolastiche, mense, personale e spazi adeguati.
Il tempo pieno è una scelta, ma spesso non si può scegliere
Oggi, teoricamente, le famiglie possono scegliere tra diversi modelli orari – 24, 27, 30 o 40 ore settimanali – come previsto dal decreto n. 89 del 2009. Ma nella pratica non è così: non tutte le scuole offrono il tempo pieno, e quindi non tutte le famiglie hanno davvero la possibilità di scegliere. Spesso questa opzione dipende dal territorio in cui si vive, dal numero di docenti disponibili, dalla presenza o meno di una mensa. Il risultato è un’offerta a macchia di leopardo.
Per l’anno scolastico 2025/2026 si raggiungerà il numero record di quasi 946.000 alunni e alunne iscritti al tempo pieno: un dato che conferma quanto questo servizio sia apprezzato dalle famiglie. Ma resta un fatto: più della metà degli iscritti e delle iscritte alla scuola primaria – oltre 2,2 milioni in totale – non potrà accedervi. Una questione non solo organizzativa, ma di giustizia sociale.
Il tempo pieno non significa solo più scuola: significa anche più socialità, più opportunità, più sicurezza. È un tempo in cui si dovrebbe poter apprendere senza fretta, con attività più distese e inclusive. È un tempo in cui si cresce insieme. Per tanti bambini e bambine, inoltre, è l’unico momento della giornata in cui si ha accesso a un pasto completo: in un Paese dove, secondo gli ultimi dati pubblicati da Istat, 1 minore su 4 è a rischio di povertà o esclusione sociale, non è un dettaglio di poco conto.
Per questo servono investimenti strutturali. Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato oltre 83 milioni di euro, grazie al PNRR, per realizzare 210 nuove mense scolastiche. Almeno il 66,3% delle risorse sarà destinato al Sud, con l’obiettivo di ridurre i divari territoriali. Ma il tempo è poco: i lavori dovranno concludersi entro marzo 2026, i collaudi entro giugno, altrimenti i fondi verranno persi.
Estendere il tempo pieno su tutto il territorio nazionale dai 3 ai 14 anni significa dare a ogni bambina e bambino le stesse possibilità, ovunque viva e contrastare le disuguaglianze educative e sociali prima che diventino irreversibili. Non è giusto che il tempo scuola cambi radicalmente da una città all’altra, o da un quartiere all’altro. Non è accettabile che chi vive in una zona svantaggiata debba ricevere meno. Il tempo pieno deve diventare un diritto, non un privilegio.
Le obiezioni più comuni alla nostra proposta (e come rispondere)
Come ogni proposta di cambiamento, anche la riforma del tempo scuola – e in particolare la rimodulazione del calendario scolastico - solleva dubbi e perplessità. Alcune critiche sono comprensibili e legittime, ma spesso si basano su informazioni parziali o su timori che possono essere affrontati coinvolgendo la comunità educante e le istituzioni. Ecco le obiezioni più frequenti alla nostra proposta e le nostre risposte.
“La scuola non è un parcheggio!”
È vero. E non stiamo dicendo che debba esserlo. La scuola non è – e non deve mai diventare – un luogo dove “tenere” bambini e bambine mentre gli adulti lavorano. È uno spazio educativo e relazionale, uno dei presìdi più importanti della nostra democrazia. È il luogo dove si cresce, si costruiscono relazioni, si scoprono le proprie inclinazioni, si impara a vivere insieme alle altre persone.
Se la scuola fosse solo un parcheggio, non ci preoccuperemmo della qualità dell’insegnamento, del benessere psicofisico degli e delle studenti, dell’equità dell’accesso. E invece, ce ne preoccupiamo eccome.
Proporre scuole aperte anche d’estate, al pomeriggio e durante le pause non significa allungare interrogazioni e compiti, ma dare spazio ad attività educative diverse: laboratori creativi, sport, lettura, teatro, gioco. Attività pensate per stimolare curiosità e socialità, in ambienti sicuri, accessibili e accoglienti, guidate da figure educative e realtà del Terzo Settore. Esperienze che già esistono sotto forma di centri estivi, spesso ospitati proprio nelle scuole, ma oggi riservate a chi può permettersele. Perché non renderle un’opportunità pubblica, disponibile per tutti e tutte?
Spesso ci viene chiesto: “Ma cosa cambia a mettere i bambini a scuola invece che in un centro estivo?” Cambia moltissimo. La scuola non è una struttura qualsiasi. È un bene comune, già radicato in ogni comunità, e ha un valore simbolico, sociale e culturale che va oltre le mura. È il primo luogo, dopo la famiglia, dove si sperimentano i diritti, si apprendono regole comuni, si costruisce cittadinanza.
Spostare bambini e bambine da una struttura all’altra, come avviene oggi in modo frammentato e spesso disuguale, non garantisce equità. Chi dispone delle risorse economiche partecipa, chi non può resta escluso. Rafforzare la funzione educativa e sociale della scuola, anche fuori dai tempi canonici, significa invece creare un presidio permanente, stabile, capace di accompagnare la crescita di tutti e tutte, non solo di chi ha più possibilità.
Inoltre, molte di queste attività si svolgono già nelle scuole: aule, palestre, cortili sono usati in estate e al pomeriggio da realtà esterne, ma senza un legame con il progetto educativo. L’idea è trasformare la scuola in un luogo vivo e coerente, che non si limiti a “ospitare” attività, ma le integri in una visione più ampia, fondata sulla continuità educativa.
Infine, c’è un aspetto fondamentale che non va mai trascurato: la socializzazione. Per tanti bambini e bambine, soprattutto nei contesti più fragili, la scuola è l’unico spazio dove incontrare coetanei e coetanee, parlare con adulti di riferimento, sentirsi parte di una comunità. Lasciarli soli per mesi, chiusi in casa o nei quartieri senza stimoli, non è una scelta neutra: è una rinuncia a garantire pari opportunità.
Per questo aprire le scuole tutto l’anno – in forme nuove, più aperte, più flessibili – non significa parcheggiare bambini e bambine, ma coltivare i loro diritti. Non è un impoverimento, ma un investimento nella coesione sociale, nella cittadinanza, nel diritto al futuro di ogni bambina e bambino.
“Le scuole non sono adatte al caldo!”
È vero: molti edifici scolastici in Italia sono vecchi, insicuri e inadatti a temperature sempre più elevate. Solo nel 2024 si sono verificati 56 episodi di crolli, con sei persone ferite tra studenti e personale. Inoltre, la maggior parte delle scuole italiane non dispone di sistemi di climatizzazione adeguati. Ma proprio per questo non basta parlare di calendario: occorre affrontare con anche la questione strutturale.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’occasione irripetibile, avendo stanziato oltre 20 miliardi di euro per l’istruzione, una cifra mai vista prima. Di questi, 1 miliardo è destinato alla riqualificazione di edifici scolastici, con l’obiettivo di ridurre del 50% i consumi energetici e migliorare le condizioni degli studenti e delle studentesse. Tuttavia, al primo trimestre del 2025, solo il 30% dei fondi era stato effettivamente speso. Una seconda linea di spesa, da 4,4 miliardi, è dedicata alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico degli edifici scolastici. Anche qui l’avanzamento è lento: meno del 33% delle risorse risultava utilizzato nello stesso periodo.
Negli uffici in cui lavoriamo, gli ambienti sono climatizzati, sicuri, spesso efficientati dal punto di vista energetico. Perché non pretendiamo lo stesso per le scuole, dove passano gran parte delle loro giornate milioni di bambini, bambine e adolescenti? È nel nostro interesse, come cittadinanza, pretendere che questi fondi vengano spesi, e spesi bene. Ma non basta stanziarli: molte scuole, soprattutto nei territori più fragili, non riescono a spenderli perché non hanno le competenze tecniche per partecipare ai bandi o gestire progetti complessi. Eppure, quei bandi non riguardano solo l’edilizia: spesso offrono anche la possibilità di ripensare l’offerta formativa, aprendo la scuola al territorio e a nuove modalità educative.
Per questo è fondamentale rafforzare le sinergie con il Terzo Settore e promuovere Patti educativi di comunità: strumenti già previsti dalla normativa, che permettono alla scuola di collaborare in modo strutturato con enti locali, associazioni, educatori, biblioteche, musei, realtà sociali e culturali. Un patto educativo di comunità è, in sintesi, un’alleanza territoriale per prendersi cura insieme della crescita e dell’educazione di bambini e bambine.
“Più pause durante l’anno renderebbero la vita delle famiglie ancora più complicata”
Non si tratta solo di “più pause”, ma di come organizziamo il tempo: scolastico, lavorativo, familiare. Una scuola aperta anche durante le pause, con attività educative gratuite o accessibili, pensate per bambini e bambine, non complica la vita delle famiglie: la rende possibile.
In Italia oggi avere figli è difficile, e ce lo dicono i dati: tassi di natalità tra i più bassi del mondo, servizi insufficienti, famiglie lasciate spesso sole. Ma questo non è un destino inevitabile: è il frutto di scelte, o di mancate scelte, politiche. Nei Paesi dove si investe in welfare e servizi pubblici, come quelli scandinavi, le famiglie non solo sono sostenute, ma vivono meglio la genitorialità.
In questo scenario, la scuola ha un ruolo cruciale. Non è solo istruzione: è un’infrastruttura sociale, una risorsa educativa, un alleato delle famiglie. Una scuola aperta tutto l’anno, con un’offerta pubblica durante le pause, aiuta i genitori che lavorano, riduce le disuguaglianze, promuove benessere. È una misura di welfare reale, non un privilegio e come tutte le buone politiche sociali, non riguarda solo chi ha figli: riguarda tutti e tutte.
Ma se vogliamo davvero sostenere le famiglie, non basta agire solo sulla scuola. Serve affrontare in modo sistemico anche i tempi del lavoro. Oggi gli orari scolastici e quelli lavorativi spesso sono pensati su logiche diverse, che mettono in conflitto cura e produttività. Bisogna cominciare a parlare seriamente di conciliazione dei tempi di vita, non come questione privata da “organizzare” individualmente, ma come bene collettivo.
Questo significa immaginare modelli integrati, in cui riforme della scuola e del lavoro procedano insieme: una settimana lavorativa di quattro giorni, forme più diffuse e garantite di lavoro agile, orari flessibili, diritto alla disconnessione, più ferie. Politiche del tempo, appunto. Che riconoscano che crescere una famiglia, educare un figlio o una figlia, prendersi cura non sono ostacoli da aggirare, ma parti fondamentali della vita. E che la qualità di quella vita dipende da come organizziamo, insieme, il tempo.
Per questo dobbiamo superare la retorica che colpevolizza chi ha figli e figlie e chiede servizi. È giusto che le famiglie pretendano supporto. È giusto che il lavoro si adatti alla vita, e non il contrario. È giusto che la scuola sia una risorsa stabile, presente, continua. È tempo di abbandonare il mito della famiglia che “ce la fa da sola” perché oggi, semplicemente, non regge più.
“Tanto ci sono i nonni”
Pensiamo solo ai nonni, che per anni sono stati investiti ufficiosamente del ruolo di caregiver, un ruolo cruciale ma mai formalmente riconosciuto né sostenuto. Sono stati, e in molti casi continuano a essere, l’architrave invisibile su cui poggia la conciliazione vita-lavoro in Italia.
Ma questo modello mostra oggi tutti i suoi limiti. Molti non possono più farlo: perché lavorano ancora, perché vivono lontano, o perché non sono in salute. E anche quando sono presenti e disponibili, la loro scelta di esserci dovrebbe essere libera e affettiva, non un ruolo strutturale imposto da un sistema che non offre alternative.
Affidare il benessere di bambini e bambine e, di conseguenza, delle famiglie al supporto familiare informale non è sostenibile né equo. Le famiglie hanno bisogno di servizi pubblici stabili, accessibili, di qualità. Hanno bisogno di sapere che scuola, lavoro e cura possono coesistere in modo umano, non a costo di sacrifici costanti o soluzioni precarie.
È su questo che si gioca la possibilità di vivere la genitorialità senza doverla sopportare, di costruire una società più equa, in cui fare figli non sia un atto di resistenza, ma una scelta compatibile con una vita dignitosa. La scuola può e deve essere una delle colonne portanti di questo nuovo patto sociale.
Chi sostiene la riforma del tempo scuola e cosa stanno facendo le istituzioni?
La proposta di rivedere il calendario scolastico e rendere le scuole aperte tutto l’anno sta guadagnando sempre più spazio nel dibattito pubblico e tra chi ogni giorno vive la scuola.
Il Piano Estate, lanciato dal Ministero dell’Istruzione, è uno degli strumenti attivi su questo fronte: con circa 150 milioni di euro stanziati nel 2025 (e 440 milioni nel 2024), il Piano finanzia attività educative e ricreative durante le vacanze estive per favorire competenze, inclusione e socialità. Non si tratta di lezioni, ma di momenti pensati per offrire esperienze culturali, sportive e formative bambini, bambine e adolescenti di scuole primarie e secondarie, statali e paritarie.
Nonostante le buone intenzioni, il Piano Estate ha mostrato alcune criticità: molte scuole non hanno aderito o non hanno comunicato tempestivamente le iniziative alle famiglie, i posti disponibili sono stati limitati, e c’è poca trasparenza sull’impiego dei fondi. A questo si è aggiunto un problema comunicativo: il Ministero ha informato le famiglie prima dei dirigenti scolastici, creando difficoltà nell’organizzazione. L’Associazione Nazionale Presidi, infatti, ha sottolineato come sia fondamentale coinvolgere e ascoltare in modo tempestivo i dirigenti scolastici, vero motore sul territorio, per far funzionare al meglio progetti come questo. In risposta, il Ministero ha riconosciuto l’errore e ha promesso un dialogo più stretto con le scuole.
Il Piano Estate è un primo passo, ma serve qualcosa di più ambizioso: una scuola aperta tutto l’anno, con servizi e personale adeguati, capace di accompagnare bambini, bambine e adolescenti in modo continuo e inclusivo. Per farlo servono investimenti seri, molto superiori agli attuali, e una visione di lungo termine.
Anche i presidi iniziano a fare proprie queste idee. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, ha parlato chiaramente di un modello scolastico superato, proponendo una rimodulazione del calendario con pause più distribuite e scuole aperte d’estate per attività culturali e sportive, non per lezioni.
Il nostro impegno per un nuovo tempo scuola
In questi mesi, abbiamo portato oltre 70.000 firme in Senato insieme a Mammadimerda. E le firme alla nostra petizione per rimodulare il calendario scolastico continuano a crescere, giorno dopo giorno. Non è solo un numero: è il segno tangibile di una richiesta reale e condivisa, che arriva da famiglie, figure educative, insegnanti, cittadine e cittadine di ogni parte d’Italia. La nostra richiesta ha acceso il dibattito pubblico e attirato l’attenzione dei media, perché tocca un punto centrale della nostra vita quotidiana: il tempo, e come lo organizziamo tra scuola, lavoro e cura. (LEGGI COSA CHIEDIAMO E FIRMA ANCHE TU)
Ma abbiamo fatto tanto altro. Abbiamo raccolto dati e ascoltato storie su cosa significhi affrontare tre mesi di vuoto educativo durante l’estate, soprattutto per chi vive in contesti fragili, dove non esistono alternative accessibili. Per molte famiglie non si tratta solo di conciliazione, ma di accesso concreto a opportunità di crescita.
Abbiamo avviato un confronto costante con insegnanti, sindacati, dirigenti, istituzioni locali e nazionali. Perché siamo consapevoli che nessuna riforma può essere imposta dall’alto: va costruita insieme a chi la scuola la vive ogni giorno, e che in questa trasformazione deve avere un ruolo centrale.
Nel frattempo, nei nostri centri educativi in tutta Italia abbiamo già messo in pratica la scuola che immaginiamo: con il nostro Piano Estate offriamo attività educative gratuite nei mesi estivi, spesso in quartieri dove rappresentano l’unica proposta disponibile. È la dimostrazione che si può fare, e che già succede.
Ma non basta. Non vogliamo restare in una dimensione sperimentale o residuale. Per questo chiediamo l’apertura di un tavolo tecnico nazionale, che coinvolga tutte le parti interessate – scuola, famiglie, Terzo Settore, sindacati, amministrazioni – per iniziare a tradurre questa visione in realtà.
Sappiamo che non sarà facile. Richiederà tempo, risorse e confronto, ma continuare a ignorare il problema ha un costo ancora più alto: lasciare indietro i bambini e le bambine che avrebbero più bisogno, e scaricare tutto sulle famiglie, che si arrangiano da sole.
In sintesi, serve un cambiamento di sistema
- Una nuova organizzazione del calendario scolastico: sempre 200 giorni di scuola, ma distribuiti meglio, con pause più brevi e regolari durante l’anno.
- Scuole aperte tutto l’anno, anche durante le pause, con attività educative gratuite o accessibili, pensate per stimolare gioco, creatività, movimento e socialità, non per fare più lezione.
- Tempo pieno garantito dai 3 ai 14 anni su tutto il territorio nazionale: un’opportunità reale per tutte le famiglie, non solo per chi vive in aree ben servite.
- Investimenti strutturali per edifici scolastici più sicuri, accoglienti, sostenibili: mense, palestre, aule climatizzate, spazi adatti a vivere bene la scuola.
- Politiche del tempo che tengano insieme scuola e lavoro, con una visione integrata: flessibilità negli orari, congedi adeguati, possibilità reali di conciliazione. Lavoro e scuola non devono essere in conflitto, ma alleati nella costruzione di una società più giusta.
Ripensare il tempo scuola è una scelta concreta e possibile. Significa costruire condizioni più eque, sostenere chi rischia di rimanere ai margini, riconoscere il valore del tempo condiviso e delle relazioni educative. Sappiamo bene che questa trasformazione richiede impegno e visione, ma ci chiediamo anche: possiamo davvero permetterci di lasciare le cose come stanno? Le disuguaglianze crescono, i servizi non bastano, e il tempo – per imparare, per crescere, per conciliare – è diventato un nodo centrale per tutte le famiglie.
Immaginare una scuola più aperta, flessibile e vicina alla vita reale non è solo necessario. È un passo che possiamo fare, insieme.