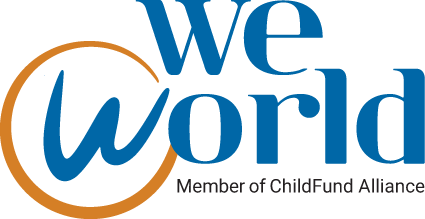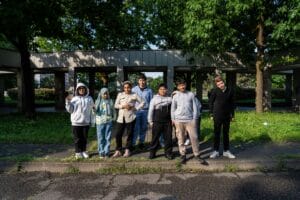Spese, disuguaglianze territoriali, difficoltà educative e sociali per bambine, bambini e adolescenti. Scopri i dati sull’estate delle famiglie italiane.
Al Sud e nelle Isole, 1 famiglia su 3 non ha iscritto i propri figli al centro estivo; tra quelle con figli con disabilità, la proporzione scende a 1 su 4. La spesa media per un’estate al centro estivo si avvicina ai 530 euro per figlio.
E ancora, sono 4 su 10 i bambini e le bambine che restano isolati, senza relazioni sociali, durante la lunga pausa estiva. In un Paese spaccato, dove i servizi non sono garantiti ovunque, chi rischia di rimanere ai margini? Lo abbiamo chiesto direttamente alle famiglie italiane, raccogliendo oltre 3.000 risposte e quasi 1.000 testimonianze.
Ecco cosa ci hanno raccontato.
La nostra ricerca lo conferma: l’estate amplifica le disuguaglianze
Ogni anno l’estate, per le famiglie italiane, è un puzzle da ricominciare da capo. Le scuole chiudono per tre lunghi mesi – una delle pause estive più estese d’Europa – e il peso dell’organizzazione ricade quasi sempre sulle spalle delle famiglie, in particolare delle donne. Trovare un centro estivo, gestire i costi, incastrare ferie e lavoro diventa un esercizio di equilibrismo continuo. Ma non è solo una questione logistica. È una questione di diritti, benessere e opportunità che, troppo spesso, vengono negate.
La pausa estiva non è uguale per tutte le famiglie. C’è chi può permettersi centri estivi, viaggi e attività e chi, invece, si trova a dover improvvisare soluzioni informali o, peggio, a lasciare bambini e bambine isolati a casa. E, per molti e molte di loro, specialmente per chi ha una disabilità, o vive in territori ai margini, l’estate diventa un tempo “vuoto”, in cui si perdono relazioni, stimoli, competenze. Il risultato? Le disuguaglianze si allargano.
Nel luglio 2025, insieme al duo Mamma di Merda – progetto di divulgazione dissacrante e ironico sulla maternità, fondato da Francesca Fiore e Sarah Malnerich – abbiamo chiesto alle famiglie italiane di raccontarci come vivono questa stagione.
Più di 3.000 famiglie hanno risposto al nostro questionario e quasi 1.000 hanno lasciato una testimonianza. Il risultato è un racconto collettivo, fatto di fatiche, ma anche di proposte che guardano al futuro.
Questa indagine vuole essere un punto di partenza per aprire un dialogo vero con le istituzioni. Vogliamo ripensare il tempo scuola a partire dal calendario scolastico, ma farlo partendo da chi la scuola la vive ogni giorno: bambini, bambine, famiglie e la più ampia comunità educante.
Con questa ricerca abbiamo esplorato:
- come si organizzano le famiglie durante l’estate e le ricadute sulla conciliazione tra lavoro e cura;
- l’accesso ai centri estivi, i costi e le differenze tra territori e condizioni sociali;
- l’impatto della lunga pausa estiva sul benessere di bambini, bambine e adolescenti, con un focus specifico su chi ha una disabilità;
- le richieste delle famiglie per ripensare il tempo scuola, a partire da un calendario più equilibrato.
Leggi la nostra proposta – “Guida alla proposta di riforma del tempo scuola”
Chi sono le famiglie che ci hanno raccontato la loro estate?
Alla nostra consultazione hanno partecipato 3.161 famiglie. Ogni risposta è risultata utilizzabile per l’analisi e ci ha consentito di costruire un mosaico più completo. A rispondere sono state soprattutto donne (97,8% del campione), mentre gli uomini sono appena l’1,9% e lo 0,3% ha preferito non indicare il genere. Anche se non abbiamo analizzato i dati in chiave di genere, questo risultato è - ancora una volta – un'indicazione che a farsi carico della gestione familiare, e del carico mentale che ne consegue, sono soprattutto le donne.
Le famiglie che hanno risposto sono molto eterogenee:
- il 39% ha un solo figlio o figlia,
- il 53% ne ha due,
- l’8% ha più di due figli,
- inoltre, il 6,2% ha figli con disabilità riconosciuta, una percentuale che arricchisce di ulteriori sfumature il racconto delle difficoltà legate all’estate.
Guardando all’età di bambini e bambine:
- 41,8% ha tra 0 e 5 anni,
- 52,7% tra 6 e 14 anni,
- solo il 6% ha più di 15 anni.
Dal punto di vista geografico, il campione è molto sbilanciato verso il Nord Italia (74%), seguito dal Centro (18%) e dal Sud e Isole (8%). Il questionario è stato diffuso in tutta Italia, ma probabilmente i canali utilizzati per la diffusione hanno una community più attiva in alcune regioni, soprattutto del Nord. Questo potrebbe spiegare la distribuzione sbilanciata delle persone rispondenti.
Anche se non possiamo definirlo un campione statisticamente rappresentativo a livello nazionale, i dati offrono comunque uno spaccato reale e concreto delle sfide che tante famiglie affrontano ogni estate, tra figli, lavoro e gestione familiare.
Oltre alle risposte a scelta multipla, abbiamo lasciato spazio a racconti personali e ben 970 persone hanno deciso di scriverci la loro testimonianza diretta: le loro parole non solo arricchiscono i numeri, ma li rendono vivi, restituendo la complessità e le emozioni di chi vive in prima persona le difficoltà dell’estate.
“Siamo stanchissimi di vivere di incastri ed equilibrismi per tenere assieme lavoro e famiglia”.
Chi si prende cura di bambini e bambine durante l’estate?
Quando la scuola chiude, chi si occupa di bambini e bambine? La risposta è semplice: i genitori, o i caregiver, più di chiunque altro. Per quasi 1 famiglia su 2 (49,4%) la gestione estiva è a carico soprattutto della famiglia stessa, tra ferie, turni di lavoro incastrati e mille acrobazie quotidiane.
“L’Italia è una repubblica basata sui nonni. Se si ha la fortuna di averli, in salute e disponibili, è un conto, altrimenti per le famiglie è un carico difficilissimo”.
Questa responsabilità diventa ancora più gravosa per le famiglie con figli e figlie con disabilità: in questi casi, quasi 3 su 4 (76,5%) si fanno carico in prima persona della cura estiva. Una situazione simile si riscontra anche nelle famiglie numerose, con più di due figli, dove il 68,3% gestisce i mesi senza scuola autonomamente.
A livello territoriale, nel Centro Italia (66%) e nel Sud e Isole (64,2%), il carico diretto sui genitori è superiore alla media nazionale. Un segnale chiaro di come, in molte aree del Paese, la rete di supporto esterno sia più fragile, se non del tutto inesistente.
Ma quali altre opzioni hanno le famiglie?
- Nonni e parenti: la rete familiare resta fondamentale, ma non basta. Accanto ai genitori, nonni, zii e parenti rappresentano ancora un pilastro di sostegno per 4 famiglie su 10 (41%).
- Questa rete familiare è particolarmente forte nel Centro Italia (52,2%), ma rimane solida anche nel Nord (47,7%) e nel Sud e Isole (44,1%).
- I servizi pubblici raggiungono solo 1 famiglia su 5. I centri estivi pubblici (comunali o scolastici) sono utilizzati da poco più di 1 famiglia su 5 (22%). Anche qui emergono forti differenze territoriali: al Nord può accedervi circa 1 famiglia su 3 (30,1%), mentre al Centro (19%) e al Sud e nelle Isole (11,8%) la disponibilità di questi servizi è molto più limitata. Le famiglie con uno o due figli riescono a utilizzare di più i servizi pubblici, ma per chi ha più figli o figli con disabilità, l’accesso si complica: posti insufficienti, costi non sostenibili, mancanza di personale adeguato.
- Il privato diventa (quasi) obbligatorio. Più di 4 famiglie su 10 (42,8%) si rivolgono ai centri estivi privati. Questa opzione diventa quasi obbligata nel Centro Italia, dove il 55% delle famiglie vi ricorre, e resta molto diffusa anche al Nord (50,4%). Anche le famiglie numerose si affidano spesso al privato (48,8%).
- Parrocchie e associazioni: un aiuto per le famiglie più numerose. I centri parrocchiali e le associazioni rappresentano un altro punto di riferimento, anche se meno diffuso: vengono frequentati dal 18,1% delle famiglie. Sono più presenti al Nord (21%) e sono particolarmente apprezzati dalle famiglie con più di due figli (26,2%).
“Gli standard qualitativi dei centri estivi comunali o parrocchiali sono molto bassi, sia in termini di proposta educativa che di sicurezza. L'offerta più o meno ricca di proposte articolate su calendari settimanali non tiene conto delle esigenze dei bambini con difficoltà relazionali, che non hanno tempo e modo di adattarsi ai nuovi contesti”.
- Babysitter e figure educative private: una soluzione di nicchia, ma fondamentale. Solo 1 famiglia su 10 (11%) riesce ad affidarsi a babysitter o educatori/educatrici privati. Questa scelta, più personalizzata e tendenzialmente più costosa, è più frequente nel Sud e Isole (16,9%), nel Centro Italia (15,5%), e tra le famiglie numerose (17,5%) o con figli con disabilità (12,8%).
- Il Piano Estate: un’occasione mancata per molte famiglie. Nato per offrire attività educative e ricreative durante la chiusura scolastica, il Piano Estate del Ministero dell’Istruzione avrebbe dovuto essere un sostegno concreto per le famiglie. Ma nella realtà, la sua diffusione è stata molto limitata. Solo 1 famiglia su 20 (5,9%) ha dichiarato che i propri figli hanno partecipato alle attività del Piano Estate. Un altro 9% segnala che la scuola aveva aderito, ma la famiglia non ha potuto partecipare. La maggioranza – oltre 1 famiglia su 2 (52,3%) – riferisce che la propria scuola non ha aderito, mentre circa 1 su 3 (33%) non era nemmeno a conoscenza dell’iniziativa. Le differenze territoriali sono evidenti: nel Centro Italia la partecipazione raggiunge appena il 7%, mentre nel Sud e nelle Isole scende al 4,2%, con 2 scuole su 3 (66%) che non hanno aderito e una scarsa informazione tra le famiglie. Nel Nord, la situazione è solo leggermente migliore della media nazionale.
“La comunicazione di proposta del “Piano Estate" è arrivata praticamente a luglio, quando noi famiglie già ci eravamo organizzate con iscrizioni ai centri estivi. In ogni caso, la proposta consisteva in un corso di inglese solo per alcuni gradi di scuola primaria e un corso di musica solo per alcuni gradi di scuola secondaria di primo grado, il tutto nel periodo di settembre poco prima che inizi la scuola. Non la trovo assolutamente una proposta valida, mi sembra solo una presa in giro che crea oltretutto ancora più disparità.”
Le conseguenze sul lavoro quando la scuola chiude: una fatica che riguarda 7 famiglie su 10
Quando finiscono le scuole, la conciliazione tra cura dei figli e lavoro diventa una sfida quotidiana per moltissime famiglie italiane. Solo circa 1 su 3 (30,5%) riesce a mantenere invariata la propria routine lavorativa. Per il restante 70%, invece, il periodo estivo significa riorganizzarsi, inventare soluzioni e, spesso, fare sacrifici in termini di tempo, energie e reddito.
Le strategie più diffuse sono quelle “fai-da-te”: più di 1 famiglia su 4 (25,7%) alterna le ferie con il o la partner per coprire tutto il periodo estivo, un’altra quota simile sceglie di ridurre l’orario di lavoro (24,4%) o prova a chiedere maggiore flessibilità o smart working (23,7%).
“Il carico mentale per le donne in estate aumenta in modo esponenziale. L’offerta scolastica pubblica italiana è totalmente disallineata con la realtà lavorativa.”
“Se non ci fossero i nonni non potrei lavorare!”.
“Io non lavoro perché non avendo grossi aiuti ho dovuto lasciarlo. Un periodo scolastico più spezzato, un tempo pieno durante l'anno e un’offerta scolastica garantita anche ad agosto mi permetterebbero di tornare a lavorare non solo per un guadagno economico, ma anche per evitare il burnout di cui io e tanti genitori soffriamo”.
1 famiglia su 8 (12,5%) segnala altre soluzioni, quali prendere aspettative non retribuite, portare i figli sul posto di lavoro o ricorrere al congedo parentale. Il 4,6% ha rinunciato a incarichi professionali e il 5,1% (1 persona ogni 20) ha lasciato il lavoro.
Per le famiglie con figli con disabilità o numerose, la conciliazione è quasi impossibile
Le famiglie con figlie e figli con disabilità affrontano ostacoli ancora più grandi: più di 1 genitore su 10 ha dovuto lasciare il lavoro per mancanza di alternative, una percentuale doppia rispetto alla media nazionale. Solo 1 famiglia su 4 è riuscita a mantenere invariata la propria organizzazione lavorativa. Anche l’accesso a modalità flessibili risulta più difficile.
Una situazione simile si registra tra le famiglie numerose (più di due figli), dove quasi 1 genitore su 10 ha dovuto rinunciare al lavoro e circa il 6% ha perso opportunità professionali.
Le famiglie con un solo figlio riescono invece a cavarsela un po’ meglio: più di 3 su 10 dichiarano di non aver dovuto modificare l’organizzazione lavorativa e si affidano con più facilità a soluzioni temporanee. Chi ha due figli, invece, si mantiene in linea con la media nazionale.
“Lavoro a scuola, quindi ho due mesi a casa. Sono la mamma, ma passare due mesi a casa da sola con due bambini, nonostante li abbiamo iscritti entrambi al centro estivo per due settimane (di più non possiamo permettercelo), è estenuante, per me, ma anche per loro. Arriviamo a settembre che io sono esaurita e loro sono stanchi e annoiatissimi. Per quanto io cerchi di organizzare qualcosa, di sentire amici, o di chiedere aiuto ai nonni, non è semplice: i miei genitori lavorano ancora, e i nonni paterni hanno problemi fisici e non riescono a tenere soprattutto il piccolo. Così, ogni giorno, li porto in parchi giochi diversi (quando il caldo lo permette), in piscina, a fare passeggiate, cerco di inventarmi sempre qualcosa, ma alla fine mi sembra di essere più la loro animatrice che la loro mamma.”
Quante famiglie scelgono i centri estivi? 8 su 10, ma con grandi differenze territoriali e familiari
Circa 8 famiglie su 10 (81%) ci hanno detto di avere iscritto almeno un figlio o figlia a un centro estivo. Tuttavia, questa scelta varia molto a seconda di dove si vive, della composizione della famiglia e della presenza di figli con disabilità.
Al Nord la partecipazione è la più alta, con quasi 9 famiglie su 10 (84%) che scelgono i centri estivi (comunali, scolastici, parrocchiali, ecc.). Al Centro la quota scende a 3 su 4 (76%), mentre al Sud e nelle Isole solo poco più di 2 su 3 (67%) si affidano a questi servizi, segnando un divario significativo rispetto alla media del campione generale.
Le famiglie con figli o figlie con disabilità partecipano meno (circa 7 su 10, 73%), probabilmente per difficoltà di accesso o per un’offerta di servizi inclusivi ancora insufficiente.
“Mia figlia ha una disabilità cognitiva e, sebbene siamo riusciti a trovare un centro estivo che la accoglie per quattro settimane con il supporto di un’operatrice sociosanitaria dedicata per otto ore al giorno, ha incontrato molte difficoltà nell'affrontare il cambiamento di ambiente, dei compagni e della routine quotidiana. Per lei, e per l’equilibrio organizzativo della nostra famiglia, sarebbe stato sicuramente meglio poter svolgere attività estive all’interno degli spazi scolastici che già conosce, insieme ai compagni con cui ha stretto già amicizia".
Guardando alla composizione familiare, le famiglie con due figli sono le più propense a iscrivere i figli ai centri estivi (85%), seguite da quelle con più di due figli (81%) e infine da quelle con un solo figlio (76%).
Quanto tempo passano i bambini e le bambine ai centri estivi?
La maggior parte delle famiglie sceglie di mandare i figli ai centri estivi per 3-4 settimane (38%). Circa 1 famiglia su 4 (24%) preferisce periodi di 5-6 settimane, mentre un altro 23% prolunga la frequenza per più di 6 settimane. Solo il 15% opta per esperienze più brevi, di 1-2 settimane.
Nelle regioni del Sud e delle Isole, quasi 2 famiglie su 3 (64%) scelgono periodi di 3-4 settimane. Inoltre, più di 1 su 3 (34%) prolunga la permanenza per oltre 6 settimane. In queste aree, la durata media è di 4,4 settimane.
Al Nord, la media sale leggermente a 4,5 settimane, mentre al Centro Italia si attesta a 4,3 settimane.
Le famiglie con figli con disabilità seguono un modello simile a quello del Sud: la maggior parte frequenta per 3-4 settimane, e una parte importante arriva a 5-6 settimane, con una durata media complessiva di 4,4 settimane.
Quanto spendono le famiglie?
La fascia di spesa più comune si situa tra i 200 e i 500 euro per figlio per tutta l’estate, con quasi 4 famiglie su 10 (43,5%). Seguono le spese tra 500 e 1000 euro (36,4%) e quelle sotto i 200 euro (12,1%). Il 7,3% delle famiglie supera i 1000 euro di spesa.
“Più di 2000 euro spesi per i centri estivi, svariati soldi per la babysitter che li va a prendere alle 16 e ci aspetta fino alle 19. L'estate è un incubo”.
Al Sud e nelle Isole le spese sono più contenute: quasi 1 famiglia su 4 (23,6%) spende meno di 200 euro, e solo il 4,3% supera i 1000 euro. Qui la spesa media è di circa 430 euro, la più bassa tra le aree geografiche.
Al Nord la spesa media è invece la più alta, intorno ai 540 euro a figlio, con quasi il 44% delle famiglie che si colloca tra 200 e 500 euro e il 37% tra 500 e 1000 euro. Il Centro si posiziona a metà strada, con una spesa media di 519 euro e una quota leggermente più alta di famiglie che spendono meno di 200 euro (14,6%).
Le famiglie con figli con disabilità affrontano costi mediamente più elevati, con una spesa media di circa 543 euro e una quota del 10,5% che supera i 1000 euro, per via dei servizi specialistici richiesti.
E chi non ha potuto o voluto ricorrere ai centri estivi?
Tra le famiglie che non hanno iscritto i figli ai centri estivi, più di 1 su 3 (38,4%) ha speso meno di 200 euro per altre soluzioni, spesso informali, o attività non strutturate. Tuttavia, ben il 35,7% non sa o non ricorda quanto ha speso, il che potrebbe essere segno di una gestione poco tracciata e frammentata. In generale, la media per queste soluzioni alternative si attesta intorno ai 338 euro a figlio per tutta l’estate.
Al Nord le spese sono simili alla media (330 a figlio), con il 40,3% sotto i 200 euro. Al Centro cresce la quota di chi spende di più, con il 10,4% tra 500 e 1000 euro e il 7,4% oltre i 1000 euro, per una media a figlio di 362 euro. Al Sud e nelle Isole la situazione è più varia: il 29,8% spende poco, il 16,7% spende tra 200 e 500 euro, ma il 42,9% non ricorda la spesa. In generale, al Sud e nelle Isole le famiglie si ritrovano a spendere una media di 332 euro a figlio.
Le famiglie con figli con disabilità mostrano un quadro più complesso: il 34,6% spende poco, ma il 13,5% ha costi superiori ai 1000 euro, con una spesa media di circa 460 euro, più alta della media generale, a causa delle necessità di servizi specialistici.
Un'estate a perdere: le conseguenze sul benessere di bambini e bambine
Stare con amici e amiche e giocare insieme è fondamentale per la crescita di bambini e bambine. Non si tratta solo di divertirsi, ma anche di imparare, confrontarsi tra pari e sentirsi bene. Ma durante l’estate, molti bambini, bambine e adolescenti italiani perdono questa possibilità.
Nel complesso, poco più di 6 famiglie su 10 (58%) dicono che i loro figli sono riusciti a mantenere rapporti con amici o compagni di scuola. Questo significa che in 4 famiglie su 10 (42%), bambini e bambine non hanno potuto esercitare questo diritto alla socialità.
“Mio figlio passa otto ore al giorno dai nonni in pensione senza possibilità di vedere i coetanei”.
“Quando vedo i miei figli in estate vedo dei treni che deragliano, talvolta le mete sono veramente sorprendenti, sono rilassati e scoprono il giardino, il disegno, il disordine... talvolta le mete sono molto desolanti, il perpetuarsi della noia, la sofferenza per essere spesso spostati, ripresi e rispostati, la rabbia, la solitudine, la stanchezza di tutte le ore sotto il sole al centro estivo”.
Le differenze tra le regioni sono importanti: nel Nord, 6 famiglie su 10 (61%) dicono che i figli hanno mantenuto i contatti sociali, al Centro sono più di 1 su 2 (51%), mentre nel Sud e nelle Isole meno di 1 su 2 (48%). Per i bambini e le bambine con disabilità la situazione è ancora più difficile: poco più di 4 famiglie su 10 (44%) hanno visto i figli socializzare, mentre più di 1 su 2 (56%) dice che i figli hanno vissuto un’estate senza amici o compagni.
Tra le famiglie che dicono che i figli non hanno mantenuto contatti, quasi 6 su 10 (58%) pensano che questa mancanza abbia causato sofferenza.
“Mancano totalmente attività e luoghi di aggregazione accessibili, veramente appropriati e attraenti per i ragazzi adolescenti che finiscono per vagare nei centri commerciali”.
“Mio figlio mi chiede tutti i giorni di giocare con dei bambini”.
“È sempre difficoltoso riuscire a mantenere le relazioni con i compagni durante l’estate. I figli unici soffrono maggiormente la solitudine estiva. A settembre spesso è tutto da ricostruire, quando sono piccoli se passano mesi si "dimenticano" dell’amicizia”.
Che succede quando si perdono anche le competenze scolastiche?
La perdita di competenze non è un fatto temporaneo: è un processo che si accumula nel tempo e può avere conseguenze serie come bocciature, abbandono scolastico, aumento della povertà educativa. La forbice delle disuguaglianze si allarga ogni anno di più, colpendo soprattutto chi non ha accesso a opportunità di apprendimento continue, anche durante l’estate.
La lunga pausa estiva si riflette non solo sul benessere, ma anche sull’apprendimento dei bambini e delle bambine. Quasi 1 famiglia su 2 (46%) segnala difficoltà nella ripresa della scuola a settembre, mentre circa 1 famiglia su 3 (31%) osserva una perdita di competenze scolastiche o un peggioramento nel comportamento e nei rapporti sociali.
“Ritengo che così tanti mesi a casa "senza scuola" non siano un bene per i nostri figli. Ci sono i compiti delle vacanze è vero, ma prendiamo come esempio il caso di mia figlia, che ama andare a scuola ed è bravissima: in questi mesi ha poca voglia di fare i compiti perché poco stimolata e si è disabituata al contesto scolastico”.
“Mio figlio ha paura ad affrontare situazioni per lui nuove e a settembre è sempre un dramma ricominciare tra notti insonni e crisi di pianto”.
Le differenze territoriali sono evidenti: nel Nord i dati sono molto simili alla media generale, con 1 famiglia su 3 (31%) che nota perdita di competenze e quasi 1 su 2 (46%) che fatica a riprendere la scuola. Al Centro, aumenta l’attenzione ai peggioramenti comportamentali, con 1 famiglia su 3 (33%) che li percepisce. Nel Sud e nelle Isole, meno famiglie segnalano perdita di competenze (1 su 4, cioè 26%), ma quasi 4 su 10 (38%) lamentano peggioramenti nei rapporti sociali, probabilmente legati a un’offerta di attività estive più limitata.
Per le famiglie con figli con disabilità, il quadro è ancora più delicato: quasi 4 su 10 (40%) notano una perdita di competenze scolastiche, oltre 1 su 2 (54%) segnala difficoltà nella ripresa a settembre, e circa 4 su 10 (43%) osserva un peggioramento nelle relazioni o nel comportamento.
Anche l’età dei figli e delle figlie incide molto. Tra i più piccoli e le più piccole (0-5 anni), circa 2 famiglie su 10 (20%) notano perdita di competenze, mentre questa percentuale sale a oltre 4 famiglie su 10 (42%) tra i bambini e le bambine da 6 a 14 anni e raggiunge quasi la metà (44%) per gli e le adolescenti oltre i 15 anni. Le difficoltà nella ripresa a scuola aumentano con l’età: sono segnalate da 4 famiglie su 10 (44%) con figli piccoli, salgono a metà (51%) tra i 6-14 anni e superano il 57% tra gli over 15. Peggioramenti comportamentali o relazionali sono leggermente più frequenti tra i bambini e le bambine piccole (32%) rispetto ai ragazzi e alle ragazze più grandi (circa 30%).
“Ho due figli adolescenti e contrariamente a quanto credessi quando erano piccoli (ovvero che crescendo la situazione estiva sarebbe stata più gestibile) è ancora peggio. La maggior parte delle proposte sono per bambini piccoli, per gli adolescenti c'è poco o nulla e sono in un'età fragile, in cui passano la giornata a casa da soli.”
C’è chi rischia di pagare un prezzo ancora più alto: l’estate di bambini e bambine con disabilità
L’estate dovrebbe essere tempo di gioco, scoperte e nuove amicizie. Ma come abbiamo visto, non per tutti e tutte è così. Diversi fattori incidono su quanto un’estate sia ricca di opportunità o, al contrario, rischi di essere vuota: il luogo in cui si vive, le risorse economiche delle famiglie, l’offerta di attività estive sul territorio. Per i bambini e le bambine con disabilità, questi ostacoli spesso si sommano, amplificando le distanze. È così che la lunga pausa scolastica rischia di trasformarsi in una doppia disuguaglianza: le barriere quotidiane non scompaiono, e trovare spazi realmente adatti e sensibili, dove trascorrere il tempo libero in sicurezza e serenità diventa una sfida in più.
I dati che emergono dalla nostra consultazione lo raccontano chiaramente. Poco più di 1 famiglia con figli con disabilità su 3 (35,2%) è riuscita a trovare un centro estivo accessibile o con un supporto adeguato per almeno uno dei figli. Di queste, quasi 1 su 4 (24%) ha trovato una soluzione per un solo figlio, mentre appena l’11,2% ha potuto contare su un’offerta per tutti i figli. Un altro 29,6% delle famiglie ha trovato un supporto “parziale”, un compromesso che spesso significa servizi non realmente calibrati sui bisogni dei bambini e delle bambine.
In altre parole, ci si “accontenta” di soluzioni che funzionano solo in parte. E c’è anche chi resta completamente fuori: quasi 1 famiglia su 5 (19,4%) non ha trovato nessuna soluzione accessibile per l’estate.
“Per i ragazzi e le ragazze con disabilità, le opzioni estive sono poche e spesso molto costose. Il Piano Estate si è tradotto in un numero limitato di attività, frammentate e non continuative, che non garantiscono una reale copertura durante il periodo estivo. Tutto viene lasciato sulle spalle delle famiglie, sia dal punto di vista organizzativo sia economico.”
Quando abbiamo chiesto se le proposte estive per bambini e bambine con disabilità siano sufficienti, solo il 4,6% delle famiglie ha risposto positivamente: praticamente, 1 su 20. Al contrario, quasi 2 famiglie su 3 (63,3%) ritengono che le offerte attuali non siano affatto sufficienti. C’è poi un 24,5% che riconosce l’esistenza di buone proposte, ma solo in alcune zone o per specifiche disabilità.
Terapie estive: la continuità non dovrebbe essere un privilegio
Oltre al tema dei centri estivi, abbiamo indagato anche la questione della continuità terapeutica. Durante l’anno scolastico, quasi 1 famiglia su 6 (17,8%) ha un figlio o figlia che frequenta percorsi terapeutici come logopedia, psicomotricità o riabilitazione. A queste si aggiunge un ulteriore 2,4% con più di un figlio coinvolto.
“La neurodivergenza di mio figlio (ADHD) ci permette di programmare attività in linea con quelle degli altri bambini della sua età. Quello che però osservo, con crescente frustrazione, è la pesante discriminazione che colpisce durante tutto l’anno scolastico i bambini con disabilità a spettro più ampio, come l’autismo. Troppo spesso, a questi bambini vengono precluse attività semplicemente perché chi le organizza o le conduce non possiede alcuna competenza in materia, né si preoccupa di integrare figure di supporto adeguate quando sarebbe necessario.”
Ma cosa succede in estate? Solo circa 1 famiglia su 4 (23,9%) è riuscita a garantire la continuità delle terapie senza interruzioni. Un ulteriore 19,6% ha potuto proseguire i percorsi, ma con grandi difficoltà logistiche. E poi ci sono le esclusioni vere e proprie: il 22,9% (quindi più di 1 famiglia su 5) non è riuscito a garantire la prosecuzione delle terapie, con il rischio concreto di vanificare i progressi ottenuti durante l’anno scolastico.
Le famiglie chiedono un nuovo tempo scuola
Non ci siamo fermate all’estate: abbiamo voluto sapere anche come le famiglie affrontano il resto dell’anno. Perché l’estate, con le sue disuguaglianze, è solo la manifestazione più evidente di un sistema che non funziona più. Per questo, con la nostra campagna insieme a Mamma di Merda “Ristudiamo il calendario” – e la petizione che ha già raccolto oltre 75.000 firme – proponiamo di ridisegnare il tempo scuola, per renderlo più vicino alla vita reale delle famiglie e garantire i diritti di bambini e bambine, senza ampliare le disuguaglianze.
“Da insegnante ritengo che la pausa estiva sia troppo lunga e sarebbe molto più efficace distribuire le pause in modo più omogeneo durante l'anno. Da genitore ho rinunciato a un lavoro full time perché con gli orari di nidi/scuole pubblici è impossibile conciliare in autonomia”.
Il tempo pieno a scuola non è solo un orario più lungo: per molti bambini e bambine è una risorse educativa fondamentale, e per tante famiglie è una condizione essenziale per poter lavorare e gestire gli impegni quotidiani. Eppure, in Italia, la sua disponibilità cambia radicalmente a seconda di dove si vive, creando divari che finiscono per protrarsi nel tempo.
Stando alla nostra ricerca, 7 famiglie su 10 (69,5%) dichiarano che la scuola dei propri figli offre il tempo pieno, ma le differenze territoriali sono fortissime: al Nord e al Centro la copertura supera il 70% (70,6% e 72,4%), mentre al Sud e nelle Isole scende a poco più di 1 bambino su 2 (53,5%). Il dato opposto è forse ancora più eloquente: al Sud il 35,4% delle scuole non offre affatto il tempo pieno (più di 1 su 3), il doppio rispetto al Nord (17%) e al Centro (18,2%). Questo significa che per moltissime famiglie, la possibilità di scegliere non esiste.
“Penso che la società sia cambiata e che tre mesi di chiusura estiva siano davvero troppi. Vivo in un paesino e i centri estivi ci sono solo fino a fine luglio: agosto e metà settembre diventano una corsa continua per riuscire a incastrare i bambini da qualche parte, perché sia io che mio marito lavoriamo. Credo che si potrebbe fare come in Svizzera: garantire il tempo pieno, distribuire meglio le pause durante l’anno scolastico, così che i bambini non arrivino a giugno esausti, e accorciare invece la pausa estiva, visto che a settembre molti di loro non vedono l’ora di tornare alla loro routine.”
La domanda di un tempo pieno più esteso è forte in tutto il campione: quasi 6 famiglie su 10 (58,3%) vorrebbero un tempo scuola più lungo. Nel Sud e nelle Isole, dove il servizio è meno diffuso, il bisogno cresce: il 65% (quasi 2 su 3) delle famiglie chiede un ampliamento, con quasi la metà (49,6%) che lo considera essenziale. Anche al Nord (57,4%) e al Centro (59,2%) la richiesta rimane altissima.
Anche questa estate ha parlato chiaro
I dati che abbiamo raccolto non ci hanno sorpreso. Sono numeri che confermano una realtà che le famiglie che ascoltiamo da anni conoscono bene: l’estate, per tante persone, non è solo una pausa scolastica. È un periodo complicato, che amplifica le fragilità del sistema e lascia troppi genitori soli a gestire difficoltà che si ripetono ogni anno.
Le disuguaglianze si allargano, la conciliazione tra lavoro e cura diventa quasi impossibile. Le famiglie con figli e figlie con disabilità si scontrano con una mancanza cronica di servizi adeguati, costretti spesso a soluzioni a pagamento, quando ci sono. E chi non ha una rete familiare di supporto si ritrova davanti a scelte impossibili, tra il lavoro e il benessere dei propri figli.
Le testimonianze che abbiamo raccolto raccontano tutto questo. Parlano di genitori che arrivano a settembre stremati, di bambini e bambine che vivono estati troppo lunghe, senza proposte adatte a loro. Ma raccontano anche idee per cambiare: un calendario scolastico più equilibrato, un tempo pieno accessibile su tutto il territorio, e un’estate che garantisca continuità educativa e sollievo alle famiglie.
Non avevamo bisogno di questi dati per sapere quanto tutto questo fosse urgente. Ma i dati servono per costruire politiche, per pretendere che la realtà di chi vive queste difficoltà ogni anno venga finalmente ascoltata. È una questione di diritti, di giustizia sociale, di non lasciare nessuno ai margini.
Con la campagna “Ristudiamo il calendario”, vogliamo portare queste richieste alle istituzioni. Grazie a tutte le famiglie che hanno partecipato e continueranno a farlo: la vostra voce ci aiuterà a portare queste richieste più lontano.