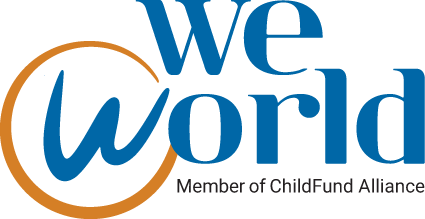L’assenza di educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole in Italia continua a esporre le giovani generazioni a disinformazione e a rischi. Serve un cambiamento.
Anche quest’anno si torna a scuola. Ma tra matematica, geografia, scienze e storia, manca all’appello una materia fondamentale per la crescita e il benessere di ragazze e ragazzi: l’educazione alla sessualità e all’affettività. Una grande assente nei programmi scolastici italiani, eppure cruciale per costruire relazioni sane, consapevoli e rispettose. In un momento in cui la scuola riapre le porte, dobbiamo chiederci: cosa stiamo insegnando davvero alle nuove generazioni su emozioni, corpo, consenso, identità? E cosa lasciamo invece al silenzio, ai tabù, al caso?
Ma andiamo con ordine…
Cos’è (davvero) l’educazione sessuale e affettiva?
Contrariamente alla percezione generale, l’educazione sessuale e affettiva non è (e non dovrebbe essere) solo un elenco di informazioni su anatomia o contraccezione. È molto di più: è un percorso educativo che parla di corpi, relazioni, emozioni e diritti.
Educare alla sessualità e all’affettività significa parlare di consenso, rispetto dei confini, gestione delle emozioni, violenza di genere, relazioni sane, autodeterminazione. Significa riconoscere che la sessualità è parte della nostra identità e che ogni persona ha il diritto di viverla con libertà e consapevolezza.
Parlare apertamente di corpo, emozioni e relazioni non è un privilegio né un’ideologia. È un diritto delle nuove generazioni, un gesto concreto di cura e uno degli strumenti più efficaci per prevenire la violenza, come ci ricorda la Convenzione di Istanbul. Si tratta di un accordo internazionale che impegna i Paesi firmatari a prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica.
Secondo le linee guida dell’UNESCO e dell’OMS, il modello da seguire per una corretta educazione asessuale affettiva è quello della Comprehensive Sexuality Education (CSE): un processo continuo, graduale, basato su evidenze scientifiche, che comincia fin dalla scuola primaria e cresce insieme a chi lo riceve, adattandosi all’età e alla maturazione di ogni bambino, bambina e adolescente.
La CSE si fonda su quattro pilastri essenziali:
- Scientificità: contenuti aggiornati, accurati e senza pregiudizi.
- Accessibilità: linguaggio chiaro, adatto all’età e comprensibile a tutte e tutti.
- Inclusività: rispetto per ogni identità di genere, orientamento, abilità e origine culturale.
- Benessere: aiutare bambini, bambine e giovani a vivere corpo e relazioni in modo consapevole, libero e sereno.
Nei Paesi dove la CSE è realtà da anni, i risultati parlano chiaro: meno gravidanze precoci, meno infezioni sessualmente trasmesse, maggiore conoscenza su identità di genere e consenso, meno abusi, meno discriminazioni. In poche parole: più consapevolezza di sé, del proprio corpo e dei propri diritti.
Cosa pensano le nuove generazioni? I dati della nostra ricerca
Tra gennaio e febbraio 2025, abbiamo coinvolto oltre 300 studenti e studentesse di 26 scuole in tutta Italia per capire cosa sanno e cosa vorrebbero sapere sull’educazione sessuale e affettiva. Ecco cosa è emerso:
Un’informazione spesso assente o insufficiente
- Solo 4 giovani su 100 dichiarano di ricevere le principali informazioni su questi temi a scuola. Questo dimostra quanto l’educazione sessuale e affettiva sia ancora un argomento poco trattato nel sistema scolastico italiano, lasciando ragazze e ragazzi senza un punto di riferimento affidabile.
- Quasi la metà (48,6%) si informa principalmente su Internet, ma questo può esporre a contenuti non sempre affidabili, parziali o addirittura fuorvianti e violenti, creando confusione e alimentando miti e false credenze.
- Infatti, quasi la metà (precisamente il 44,2%) crede che l’acqua fredda possa bloccare le mestruazioni, una falsa credenza priva di basi scientifiche.
- Quasi 1 su 4 (23,5%) pensa che non si possa rimanere incinta durante il ciclo mestruale, un errore che può portare a comportamenti a rischio.
- La conoscenza delle malattie sessualmente trasmesse è disomogenea: quasi tutti e tutte conoscono l’HIV/AIDS (97,8%), ma solo la metà conosce il papilloma virus (HPV, 51,1%) e un terzo la clamidia (34,2%).
Consenso e violenza: luci e ombre
- Quasi 9 su 10 (95%) sanno cos’è il consenso: un accordo libero e reciproco. È un dato positivo che mostra una buona base per intraprendere relazioni sane.
- Tuttavia, più di 1 su 7 (14,4%) pensa che il consenso possa essere “implicito” in una relazione, un’idea pericolosa che può giustificare abusi. Inoltre, l’11,9% non considera violenza la menzogna sull’uso del preservativo, evidenziando la necessità di approfondire tutte le forme di violenza sessuale, comprese quelle meno evidenti.
Ciclo mestruale, stigma ed emozioni
- Più della metà delle ragazze vorrebbe poter parlare liberamente del ciclo mestruale, segno che questo tema resta ancora avvolto da tabù e imbarazzo.
- Quasi un terzo associa il ciclo a emozioni negative come vergogna o disagio, che si riflettono anche in gesti quotidiani: più di 1 su 4 (28,5%) si sente imbarazzata nell’acquisto di prodotti per le mestruazioni.
Quando dovrebbe iniziare l’educazione sessuale?
- Quasi la metà (49,2%) ritiene che l’educazione sessuale dovrebbe cominciare alle scuole medie, mentre un significativo 25,7% pensa sia importante iniziare già alle elementari.
- Solo una minima parte (1,6%) considera questi temi privati da affrontare solo in famiglia.
L’educazione alla sessualità e all’affettività è una responsabilità collettiva
La nostra ricerca mostra un quadro chiaro: le giovani generazioni vogliono informazioni chiare, scientifiche e inclusive. Ma la realtà educativa italiana è ancora troppo frammentata e spesso insufficiente.
“Colmare il vuoto educativo sull’affettività e sulla sessualità è una responsabilità collettiva”, ha dichiarato Valentina Rizzi, Coordinatrice dei Programmi Domestici di WeWorld, commentando i risultati.
“Non possiamo lasciare le nuove generazioni sole, esposte a contenuti sessisti, violenti o disinformati. La scuola deve diventare uno spazio di crescita, libertà e autodeterminazione, dove ogni persona, a prescindere da genere, orientamento, origine o condizione, possa conoscere sé stessa, i propri diritti e costruire relazioni basate su rispetto e consapevolezza.”
Il rischio di lasciare vuoti informativi che vengono riempiti da disinformazione è molto concreto. Per questo è urgente che le scuole, supportate da figure esperte e istituzioni, offrano programmi di educazione sessuale e affettiva completi, che vadano oltre la semplice informazione biologica, includendo anche gli aspetti emotivi, sociali e culturali fondamentali per una crescita sana e consapevole.
L’educazione sessuale e affettiva nelle scuole italiane
L’Italia è uno dei pochi Paesi europei – insieme a Bulgaria, Romania, Polonia, Lituania e Ungheria – a non prevedere percorsi obbligatori di educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Una situazione preoccupante, soprattutto se confrontata con quella di Paesi come Svezia, Germania, Francia o Paesi Bassi, dove questo tipo di educazione fa parte del curriculum scolastico fin dalla scuola primaria.
Da noi, invece, l’educazione sessuale e affettiva è ancora bloccata da dibattiti ideologici, leggi mai approvate e decisioni politiche incerte. Dal 1975 a oggi sono stati presentati almeno 16 disegni di legge, ma nessuno è mai arrivato all’approvazione definitiva. Attualmente sono in corso quattro proposte di legge – due alla Camera e due al Senato – ma nessuna è stata calendarizzata, e nessun passo concreto è stato fatto.
In assenza di una norma nazionale, i pochi percorsi di educazione sessuale e affettiva presenti nelle scuole italiane sono frammentati e disomogenei. Dipendono spesso dalla volontà di singoli insegnanti, dirigenti o di associazioni esterne, e richiedono l’autorizzazione scritta delle famiglie. Il risultato? Un sistema in cui l’accesso a queste informazioni non è garantito a tutte e tutti.
Perché in Italia l’educazione sessuale non è una realtà diffusa?
Le cause di questo vuoto sono diverse, ma una delle principali è culturale: in Italia esiste ancora l’idea che la sessualità sia un tema “troppo delicato” per essere trattato a scuola, e che debba restare confinato all’ambito familiare. Ma se è vero che la famiglia ha un ruolo centrale nell’educazione, la scuola ha il dovere di offrire strumenti che promuovano consapevolezza, autonomia e rispetto. Insegnare a riconoscere il consenso, gestire le emozioni o proteggersi da abusi non è un’invasione, è una responsabilità educativa.
Il consenso obbligatorio: una barriera che crea disuguaglianze
Dal 30 aprile 2025, con una nuova direttiva del Ministero dell’Istruzione, il tema è diventato ancora più complesso. Su proposta del Ministro Giuseppe Valditara, e accogliendo spinte politiche da partiti di centro-destra, è stato formalizzato l’obbligo del consenso scritto delle famiglie per qualsiasi attività scolastica che tocchi temi legati a sessualità, affettività, identità di genere o altre questioni considerate “sensibili”.
La norma impone che le famiglie vengano informate almeno una settimana prima, con dettagli su contenuti, obiettivi e figure coinvolte. Senza consenso, le ragazze e i ragazzi possono essere esentati, con percorsi alternativi. Ogni proposta educativa esterna deve essere approvata sia dal Collegio docenti che dal Consiglio d’Istituto. Inoltre, l’educazione sessuale e affettiva viene esclusa dalla scuola dell’infanzia e dalla primaria, a eccezione dei contenuti previsti nei programmi di scienze.
Quali sono le conseguenze?
Questa regolamentazione, pur presentandosi come una misura di trasparenza e partecipazione, rischia di fare l’opposto: trasmettere l’idea che parlare di corpi, relazioni e identità sia qualcosa di pericoloso o inappropriato. In realtà, si tratta di temi fondamentali per il benessere, la salute e la sicurezza delle nuove generazioni.
Richiedere il consenso scritto rende l’educazione sessuale e affettiva un privilegio e non il diritto che dovrebbe essere: chi vive in famiglie aperte e informate potrà accedervi, mentre chi cresce in contesti rigidi o poco informati rischia di rimanere ai margini. In questo modo, la scuola pubblica, che dovrebbe garantire pari opportunità, acuisce le disuguaglianze invece di ridurle.
La scuola come spazio sicuro
La domanda è semplice, ma cruciale: quale ruolo vuole avere la scuola pubblica nella formazione delle nuove generazioni? Se la scuola vuole davvero garantire un’educazione equa e inclusiva, non può ignorare temi fondamentali come la salute sessuale e riproduttiva, la libertà di scelta, il consenso, la parità dei generi e la dignità di ogni persona.
Introdurre percorsi di educazione sessuale e affettiva completi e basati su dati scientifici non significa sostituire il ruolo delle famiglie, ma affiancarle. La scuola può offrire uno spazio neutro, preparato, sicuro e professionale dove bambine, bambini, ragazze e ragazzi possano parlare liberamente di temi che in famiglia spesso restano nascosti a causa di cultura, tabù o mancanza di informazioni.
In questo modo, la scuola diventa un punto di riferimento fondamentale, che fornisce strumenti per:
- riconoscere situazioni di abuso o rischio;
- rispettare sé stessi e sé stesse e le altre persone;
- comprendere i cambiamenti del corpo;
- costruire relazioni sane, libere da controllo e possessività;
- sviluppare senso critico verso stereotipi e disuguaglianze.
Il nostro impegno per l’educazione sessuale e affettiva in Italia e nel mondo
Per noi l’educazione sessuale e affettiva è un tassello cruciale per promuovere libertà, dignità e giustizia. Il nostro obiettivo non è solo informare, ma fornire alle nuove generazioni gli strumenti per conoscere il proprio corpo, riconoscere i propri desideri, scegliere in autonomia e costruire relazioni basate sul rispetto reciproco.
Ecco come lavoriamo:
- Un impegno globale: operiamo in oltre 20 Paesi, compresa l’Italia, intervenendo in scuole, famiglie, comunità e istituzioni, con programmi educativi adattati ai diversi contesti culturali e sociali.
- Linee guida scientifiche: in Italia, abbiamo contribuito a un documento condiviso dalle molte realtà della società civile che aderiscono al Gruppo CRC - insieme di organizzazioni e associazioni della società civile italiane che monitorano come viene applicata, nel nostro Paese, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - che propone un’educazione sessuale integrata nei programmi scolastici, basata sulle già citate linee guida di UNESCO e OMS. Questo approccio considera la persona nella sua interezza, valorizzando rispetto delle differenze e autodeterminazione.
- Interventi all’estero: in Paesi come Kenya, Siria, Tanzania e Palestina, promuoviamo percorsi di educazione al corpo e alle relazioni come strumento di protezione contro pratiche dannose come mutilazioni genitali femminili e matrimoni precoci, sostenendo bambine e ragazze nel conoscere i propri diritti e affermare la propria libertà.
- Educazione mestruale: inserita nei programmi di protezione e igiene, affrontiamo anche i tabù culturali che contribuiscono ad alimentare stigma e silenzio attorno al tema delle mestruazioni. Il nostro studio enCICLOpedia (2024), la prima indagine sulla povertà mestruale in Italia, ha rivelato non solo che nel nostro Paese 1 persona su 6 non può permettersi prodotti mestruali, ma anche che all’arrivo della prima mestruazioni 4 persone su 10 non sapevano cosa stesse accadendo al proprio corpo, segno di vergogna e mancanza di informazioni chiare.
- Kit educativo per figure educative non formali: per colmare la mancanza di curricula standardizzati, abbiamo creato strumenti per centri giovanili, gruppi sportivi e comunità, per parlare in modo sicuro e inclusivo di corpo, consenso, stereotipi ed emozioni.
- Laboratori in scuole e centri di Frequenza 200: proponiamo percorsi basati sulle esperienze dei partecipanti, promuovendo relazioni sane, ascolto e rispetto reciproco.
- Advocacy istituzionale: partecipiamo all’Osservatorio nazionale contro la violenza di genere, per mantenere alta l’attenzione sulla necessità di un’educazione sessuale permanente, strumento fondamentale di prevenzione culturale della violenza, sostenendo con forza l’introduzione obbligatoria dell’educazione sessuale e affettiva nel sistema scolastico italiano, come diritto fondamentale e atto di giustizia per una società più libera, inclusiva e rispettosa.