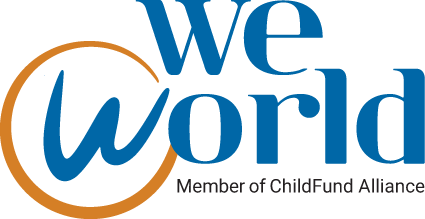Cosa pensano gli e le adolescenti italiani su corpi, emozioni e relazioni? La nostra consultazione nazionale svela bisogni e sfide in assenza di educazione all’affettività e alla sessualità.
Tra gennaio e febbraio 2025, abbiamo ascoltato direttamente la voce di ragazze e ragazzi tra i 13 e i 19 anni, coinvolgendo 319 studenti di 26 scuole secondarie italiane in una consultazione nazionale.
Attraverso il progetto educativo “Exponi le tue idee!” — quest’anno dedicato alla parità dei generi — abbiamo raccolto percezioni, bisogni e desideri su salute sessuale, benessere emotivo, identità e affettività.
Il tutto in un contesto, quello italiano, in cui manca ancora un’educazione sessuale e affettiva obbligatoria e strutturata nelle scuole. A prevalere è la frammentarietà: tutto dipende dalla sensibilità di singoli insegnanti, dalle risorse locali o da progetti esterni. Ma questa assenza non è neutra: si traduce in una disuguaglianza di accesso alla conoscenza, con effetti concreti sul presente e sul futuro di milioni di adolescenti.
Emozioni e contesti: sentire di più, o nascondere meglio?
Dalla nostra ricerca emergono segnali chiari: le emozioni non si vivono allo stesso modo, e il genere gioca un ruolo profondo, e spesso invisibile, nel determinare come si sente, si parla (o si tace) ciò che si prova.
Nel vivere le emozioni, le ragazze esprimono una maggiore intensità, soprattutto rispetto a quelle spiacevoli: rabbia, tristezza, ansia. In famiglia si sentono più spesso felici rispetto ai coetanei maschi (36,2% contro 31,3%), ma anche più frequentemente arrabbiate (30,3% vs 18%) o tristi (16,8% vs 7,8%).
A scuola, l’ansia colpisce più di 9 ragazze su 10, tra i compagni maschi il dato diminuisce leggermente ma rimane comunque significativo: più di 8 su 10.
Questa differenza non è casuale, né un fenomeno solo italiano. Studi internazionali — come quelli condotti da WHO, OECD o UNICEF — indicano da tempo che le adolescenti, nei paesi ad alto reddito, riportano livelli più elevati di ansia, depressione, insoddisfazione corporea e stress scolastico rispetto ai loro coetanei maschi. Le cause sono molteplici e intrecciate: dalla maggiore pressione sociale e scolastica, all’iper-esposizione a modelli estetici irrealistici, fino al carico relazionale ed emotivo attribuito loro nelle dinamiche familiari e amicali.
Cosa c'entra la socializzazione di genere?
La socializzazione di genere è il processo attraverso cui, fin dall’infanzia, la società trasmette ai bambini e alle bambine aspettative, norme e modelli di comportamento diversi a seconda del genere. In pratica, insegna a maschi e femmine quali emozioni è “giusto” o “accettabile” esprimere, influenzando così il modo in cui imparano a riconoscere, comunicare e gestire i propri sentimenti e, di conseguenza, a comportarsi.
Nella nostra società, le ragazze imparano fin da bambine che possono — anzi, devono — ascoltare, esprimere e gestire le proprie emozioni e, soprattutto, quelle altrui. Questa “intelligenza emotiva” viene incoraggiata, ma spesso si trasforma in un carico mentale costante, difficile da condividere o alleggerire.
I ragazzi, invece, vengono socializzati all’idea che mostrare emozioni negative sia segno di debolezza, e che la forza consista nel trattenere, minimizzare e “tenere dentro”. Nelle amicizie, felicità e fiducia prevalgono per entrambi i generi. Tuttavia, la solitudine colpisce in modo diseguale: il 17,3% delle ragazze ci ha detto che la vive con disagio, contro il 10,2% dei ragazzi. Questo si lega alle aspettative di genere: le ragazze tendono a sentirsi più responsabili del benessere relazionale e quindi più vulnerabili quando qualcosa si incrina o manca.
Strategie emotive e differenze di genere: quando il sessismo plasma le emozioni
Nel gestire rabbia o tristezza, le ragazze tendono a cercare conforto o a riflettere. I ragazzi, invece, si affidano soprattutto al controllo di sé: oltre 6 su 10 dicono di calmarsi da soli. Questo dato riflette un’abilità importante come l’autoregolazione, ma bisogna chiedersi quanto sia una reale scelta personale e quanto, invece, frutto di una pressione sociale che insegna ai maschi a non chiedere aiuto, a “farcela da soli”, a non mostrare fragilità.
I male studies, campo di ricerca sulla costruzione culturale delle maschilità, aiutano a interpretare questi dati. Studiosi come Michael Kimmel o Raewyn Connell sottolineano che i ragazzi sono indirizzati verso un’“emotività trattenuta”, dove l’espressione dei sentimenti viene filtrata o rimossa dal discorso quotidiano. Non provano meno emozioni, ma hanno meno strumenti per riconoscerle, comunicarle e gestirle.
Anche nella tristezza emergono differenze: più di ragazzo su 2 ci ha detto che preferisce la distrazione, mentre le ragazze si sentono più spesso bloccate (22,2%) o chiuse in sé stesse, con solo quasi 1 su 10 che sceglie di parlarne. La tendenza maschile a evitare il confronto emotivo può essere letta come strategia di difesa appresa, non mancanza di sensibilità.
Un dato emblematico riguarda la solitudine: quasi 6 ragazzi su 10 la vivono con serenità, contro più di 4 ragazze su 10. Per molti ragazzi, la solitudine è uno spazio “neutro” o “virile”, dove dimostrare autonomia e forza; per le ragazze, la mancanza di relazioni viene vissuta come fallimento o vuoto.
Queste dinamiche non sono innate, ma apprese e quindi modificabili, soprattutto garantendo il diritto all’educazione alle relazioni e alle emozioni. Spazi educativi inclusivi che promuovano il confronto emotivo anche tra i maschi sono fondamentali per superare le rigidità di genere che limitano il benessere emotivo degli e delle adolescenti.
Corpi, sguardi e insicurezze: un equilibrio ancora lontano
Il rapporto con il corpo mostra differenze marcate: il 57% dei ragazzi si dichiara soddisfatto del proprio aspetto, contro solo il 30,8% delle ragazze. Più di 3 ragazze su 4 (il 76,2%) vorrebbero cambiare qualcosa del proprio corpo, contro 6 ragazzi su 10 (61,7%).
Questo dato evidenzia come il corpo femminile sia spesso oggetto di giudizi legati a standard estetici imposti dalla società, che lo vedono principalmente come qualcosa da curare e rendere ‘piacevole’ agli altri, riflettendo un problema di sessismo culturale. I social media amplificano questa pressione, con immagini idealizzate e filtri che creano insicurezze: il 28,1% delle ragazze dichiara di sentirsi insicura dopo aver visto certi contenuti online, contro il 7,1% dei ragazzi.
Anche l’impatto dei commenti negativi sul corpo è molto diverso: il 90,7% delle ragazze dice di esserci stata male almeno una volta, contro il 53,1% dei ragazzi. È la prova concreta di quanto il corpo femminile continui a essere oggetto di giudizio pubblico molto più del corpo maschile. Un giudizio che spesso si traduce in disagio, vergogna, auto-censura, e nei casi più gravi in disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia e forme miste colpiscono in prevalenza le ragazze, e si manifestano sempre più precocemente, già nella preadolescenza.
Tuttavia, sarebbe un errore pensare che i ragazzi siano immuni alla pressione estetica. Anche i corpi maschili, negli ultimi anni, sono diventati oggetto di aspettative sociali più rigide: muscolosi ma asciutti, tonici ma naturali, virili ma curati. Una combinazione di standard spesso contraddittori che può generare, anche nei ragazzi, insoddisfazione e ansia da prestazione estetica. Non a caso, si registra un aumento dei casi di dismorfia muscolare (nota anche come “bigorexia”) tra i giovani maschi, un disturbo ancora poco riconosciuto ma in crescita, legato al culto della forma fisica estrema e al ricorso compulsivo all’allenamento o agli integratori.
La pressione estetica, quindi, colpisce entrambi i generi — anche se in modo diverso — e rimanda a una questione culturale più ampia: l’idea che il corpo non sia tanto uno spazio personale da abitare con libertà, quanto un oggetto da esibire, da migliorare, da conformare a parametri esterni. È proprio su questo terreno che un’educazione all’identità, al corpo e all’autonomia corporea può fare la differenza.
Salute mentale e sessuale: c'è chi chiede aiuto, e chi no
Sul fronte della salute mentale, il riconoscimento del problema è alto per tutti e tutte, ma le ragazze si sentono più libere di chiedere aiuto: quasi il 70% sarebbe disposta a rivolgersi a un professionista, contro poco più del 53% dei ragazzi. E ben un terzo dei ragazzi si dice a disagio all’idea di farlo.
È una differenza significativa: per molti ragazzi, il supporto psicologico è ancora percepito come qualcosa di “fuori ruolo”, come se ammettere un bisogno significasse mettere in discussione la propria identità maschile. Questo atteggiamento non nasce per caso, ma è da ricondurre, ancora una volta, alla socializzazione di genere.
Nel caso dei ragazzi, la socializzazione tende a promuovere l’autonomia, la forza, il controllo delle emozioni e la razionalità, spesso a discapito della vulnerabilità e dell’espressione del disagio. Le ragazze, al contrario, ricevono più incoraggiamento nel parlare delle emozioni, chiedere aiuto, prendersi cura del benessere proprio e altrui. Questo spiega perché, anche quando affrontano gli stessi problemi, le modalità di risposta siano così diverse. E perché, spesso, il disagio maschile rimane più invisibile, più sommerso, più difficile da intercettare.
Le cose non migliorano molto sul piano dell’informazione sessuale. I ragazzi si informano più frequentemente su internet (58,6% contro il 41,1% delle ragazze), ma spesso con risultati poco affidabili: quasi il 30% crede ancora che non si possa restare incinta durante il ciclo mestruale, e quasi uno su cinque pensa che in una relazione il consenso sia “implicito” — cioè scontato una volta stabilita l’intimità. Le ragazze, invece, mostrano una maggiore consapevolezza su questi temi: il 98,4% conosce il significato corretto di consenso.
Tuttavia, questa maggiore consapevolezza non significa necessariamente che le ragazze abbiano accesso a un’educazione sessuale completa o adeguata. Anche per loro le informazioni spesso arrivano in ritardo, sono frammentarie e accompagnate da vergogna o silenzi. In generale, la socializzazione di genere gioca un ruolo fondamentale: crescendo, le ragazze ricevono più messaggi legati alla prevenzione e alla cura del corpo — come visite ginecologiche o gestione del ciclo mestruale — ma spesso senza un quadro più ampio e inclusivo che coinvolga anche la conoscenza consapevole dei diritti, del consenso e delle relazioni.
Quello che cambia davvero è che alle ragazze viene attribuita una maggiore responsabilità rispetto alla salute riproduttiva e relazionale, come se spettasse soprattutto a loro “sapere”, “prevenire”, “proteggersi”. I ragazzi, invece, vengono socializzati all’idea che il corpo sia una questione secondaria, che non li riguarda da vicino, o che debbano cavarsela da soli. Questo squilibrio si riflette sia nella qualità delle informazioni che ricevono, sia nel modo in cui si vivono il proprio corpo, la sessualità e le relazioni.
Riconoscere questi meccanismi non significa colpevolizzare i singoli, ma comprendere che le differenze che osserviamo nei dati non sono innate, bensì costruite socialmente e, dunque, modificabili. Ed è proprio qui che può e deve intervenire l’educazione: per offrire a tutte e tutti gli strumenti per conoscersi, rispettarsi, tutelarsi.
Parità solo a parole?
Sulla carta, parità e rispetto nelle relazioni sono valori condivisi: il 94,6% delle ragazze e l’85,9% dei ragazzi li considerano importanti. Tuttavia, entrando nel dettaglio, emergono ancora differenze significative. Ad esempio, mentre il 94,1% delle ragazze rifiuta il controllo del partner sui social, tra i ragazzi questa percentuale scende all’84%. Questo dato rivela quanto alcuni modelli relazionali, in cui gelosia, controllo e possessività vengono ancora vissuti come normali o addirittura “romantici”, fatichino a essere superati, soprattutto tra i ragazzi.
Parlare apertamente di corpi, emozioni, relazioni e diritti non è solo una questione di parità dei generi, ma un elemento cruciale per prevenire e contrastare le forme di violenza tra pari, spesso invisibili o non riconosciute. Comprendere e rispettare i confini personali, sviluppare una solida conoscenza di sé e delle altre persone, e promuovere relazioni fondate sul rispetto reciproco sono passi fondamentali per costruire ambienti sicuri e inclusivi.
Va però considerato che nelle risposte a questionari di questo tipo può entrare in gioco la cosiddetta “desiderabilità sociale”: la tendenza a fornire risposte considerate più accettabili o conformi alle aspettative sociali. Questo può spiegare perché, pur dichiarando un forte sostegno alla parità e al rispetto, nella pratica certi comportamenti o atteggiamenti meno positivi permangono, specialmente tra i ragazzi.
Nonostante queste sfide, emerge un dato positivo: il 93,7% del campione riconosce l’importanza di un’educazione sessuale scolastica strutturata. Le ragazze, in particolare, vorrebbero che questi percorsi iniziassero già alle scuole medie (51,9% contro il 45,3% dei ragazzi), sottolineando come spesso su di loro ricada precocemente il peso di responsabilità legate al corpo e alle relazioni.
E ora? Chiediamo l’educazione sessuale e affettiva
I dati che abbiamo raccolto confermano l’urgenza di introdurre nelle scuole italiane percorsi strutturati e continui di educazione sessuale e affettiva. Non si tratta solo di prevenire disinformazione o comportamenti a rischio, ma di offrire strumenti per leggere emozioni, relazioni e corpo fuori dagli stereotipi.
In molti Paesi europei l'educazione sessuale e affettiva è da anni parte integrante dell’offerta educativa. L'Italia, dal canto suo, è tra i pochi a non offrire simili percorsi; al contrario, tutto è lasciato all’iniziativa di singoli insegnanti, progetti esterni o scelte politiche locali.
Noi di WeWorld chiediamo da tempo che l’educazione sessuale e affettiva non sia un privilegio, ma un diritto di tutte e tutti. Portiamo avanti progetti nelle scuole e iniziative di educazione non formale, nella convinzione che servano strumenti comuni, figure formate e un impianto condiviso che accompagni bambini, bambine e adolescenti nella crescita. L’educazione sessuale e affettiva è a tutti gli effetti parte dell’educazione alla cittadinanza, al rispetto e alla parità, e deve diventare un diritto garantito per tutte e tutti.
Per costruire una società davvero equa e libera, non basta dichiarare parità di diritti. Se vogliamo vera parità, dobbiamo partire da un’educazione che metta in discussione i copioni precostituiti, apra possibilità e insegni a riconoscere emozioni, rispettare i corpi e costruire relazioni sane.
Crescere liberi e libere significa non solo avere gli stessi diritti, ma anche essere messi nelle stesse condizioni di pensare, sentire e scegliere. Per questo l’educazione sessuale e affettiva non è un dettaglio, né una scelta ideologica, è una base essenziale per garantire il diritto al futuro di tutte e tutti.