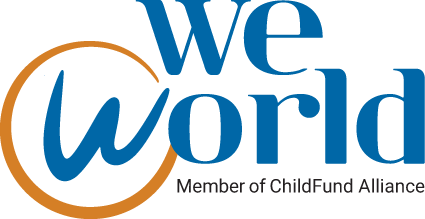Il nostro Franco De Giorgi è stato in missione in Burundi. Questo è il suo racconto dal campo per i rifugiati di Musasa.
E’ il campo più vecchio. E’ stato aperto dall’UNHCR per i rifugiati congolesi, qui in Burundi, 11 anni fa. Si trattava a quel tempo di accogliere le prime ondate di profughi in fuga dalla guerra civile nel Kivu e nel Kasai. Da allora di campi ne sono stati creati altri quattro: Bwagiriza, Kinama, Kavumu e quello di Nyankanda, che è l’ultimo e verrà riempito con gli oltre 8.000 congolesi scappati lo scorso gennaio, dopo l’ultima esplosione di violenze tra l’esercito della RDC2 e le milizie Mai-Mai.
Nella visita mi accompagna Monsieur John. E’ un rifugiato bayamulengue, coordina i volontari congolesi, che collaborano alla gestione del campo. Mentre ci addentriamo nei quartieri, tra le casette di argilla, la mia guida comincia a raccontare. Nel campo vivono 8.500 rifugiati, la maggior parte sono qui dall’inizio, da 11 anni. Vivono in famiglia, riuniti in cellule di 12 case ciascuna. Al centro di ogni cellula c’è un vasto cortile con le cucine, i foyers améliorés, concepiti per ottimizzare il consumo di combustibile, che è artificiale e fornito da UNHCR. Le cucine sono coperte da una tettoia e lo spazio è usato per ogni espressione della vita sociale del gruppo. Anche adesso, verso le dieci del mattino, c’è qualche donna che cucina, altre lavano i panni, altre ancora, assieme ad alcuni uomini, sono riunite in cerchio e chiacchierano, mentre dappertutto si vedono bambini che giocano.
Quattro cellule (48 famiglie) costituiscono un quartiere, che ha in media 240 abitanti. Nel campo ci sono dunque 35 quartieri. Ogni quartiere dispone di un punto di distribuzione di acqua potabile e di servizi igienici (docce e latrine). Tutta l’organizzazione sociale del campo, compresa la sicurezza, è gestita dal comité, il comitato dei rifugiati, che media tra i congolesi e UNHCR e ne difende in qualche modo gli interessi. I profughi ricevono mensilmente razioni alimentari scarse ma equilibrate, cash burundese (circa 2 Euro/mese/rifugiato), utensileria e attrezzature per la casa come materassi e zanzariere impregnate, inoltre all’arrivo vengono forniti loro i materiali per la costruzione della casa.
Nel campo ci sono le scuole fino a 18 anni e un centro di salute, che offre gratuitamente a tutti assistenza e cure. A fronte di patologie maggiori, i pazienti vengono riferiti agli ospedali burundesi, sempre in regime di gratuità. Nel centro di salute lavorano un medico, 5 infermieri, 2 ostetriche, un laboratorista, una psicologa, due assistenti sociali e vari volontari scelti tra i rifugiati. Il sistema sanitario nel campo e i rapporti con quello nazionale sono affidati a GVC. Le casette, raccolte attorno alle loro corti, hanno un aspetto curato e ridente. Sono in terra, ma abbellite da colori vivaci, rosso, arancio, ocra, con decorazioni in bianco. I rifugiati si raccolgono per etnia, anche se i più numerosi sono i bayamulengue. Si tratta di tutsi, emigrati in Congo dal Ruanda già due secoli fa e che tutt’ora non sono considerati dagli altri dei “veri congolesi”. John mi spiega che le loro capanne sono senz’altro le più belle, le più accoglienti e pulite. Loro preferiscono cucinare in casa e riservare lo spazio comune ai lavori e alle chiacchiere. Tra i rifugiati qualcuno ha più spirito d’iniziativa degli altri e apre un piccolo negozietto, un “ristorante”, una rivendita di carbone di legna, altri si sono organizzati degli atelier di falegnameria e producono mobili d’arredamento. Sono comunque eccezioni: la maggior parte degli adulti, dalla fine della scuola in poi non fa assolutamente niente. Un gruppo di donne fra i 30 e i 40 anni è riunito a chiacchierare, mi invitano a sedermi con loro e a échanger un peu. Alte e belle, eleganti nei loro panni variopinti. Sono curiose, vogliono sapere tutto di me. Conosco così Aline (3 figli), Zaabu (7 figli), Melanie (6 figli), Matilde (2 figli), Niabes (solo un figlio, ammette dispiaciuta). Vengono tutte dal Sud Kivu, sono qui da 11 anni e non ne possono più. Hanno comunque da fare: tirare su i bambini, cucinare, rigovernare e lavare i panni, qualcuna è riuscita a ricavare un piccolo orticello per arricchire la dieta del PAM, monotona e insipida. Gli uomini? Quelli non fanno niente, vagabondano per il campo, sono depressi e rassegnati. E loro, le donne, loro cosa sognano? Sperano di tornare in Congo? Jamais plus!
UNHCR ha promesso, che saranno reinstallate in altri paesi. Chi pensa al Canada, chi alla Svezia, anche Roma va bene. Dopo 11 anni sperano ancora? Mais oui, bien sûr! Josiane con i suoi tre figli, quella che abitava proprio lì, è stata presa solo due mesi fa in Australia. Sono eccitate e convinte. John mi sussurra, che Josiane era gravemente invalida e senza marito. Sono poche decine all’anno quelli che riescono ad andarsene e adesso anche gli USA non ne vogliono più sapere dei rifugiati. Poi si alzano, è finita la scuola e vanno a prendere i figli. Le accompagno. Alle 12 in punto suona una campana e dalla scuola sciamano fuori a centinaia i bambini in festa. Vestiti di stracci e allegri come sempre, sono tutti nati qui e tutto sommato non se la passano male. Per i loro compagni burundesi, che abitano appena fuori dal campo, comincia un duro pomeriggio di lavoro: mentre tornano a casa devono raccogliere la legna, poi andare al pozzo, poi occuparsi a scalare dei fratellini più piccoli, fino al pasto serale fatto di farinata di manioca o di mais e poco altro. Loro li invidiano quelli del campo, “quelli che gli danno tutto gratis”. C’è in effetti questa contraddizione di fondo su cui riflettere. I bisogni primari dei rifugiati sono soddisfatti a tempo indeterminato, per i burundesi invece la vita è molto più dura e il futuro incerto. Devono pagarsi tutto, la scuola, la salute e, in alcuni rari casi, un costoso viaggio della speranza verso paesi, che li accoglieranno male e li tratteranno peggio. Ci penso su, mentre Monsieur John mi riaccompagna alla macchina.